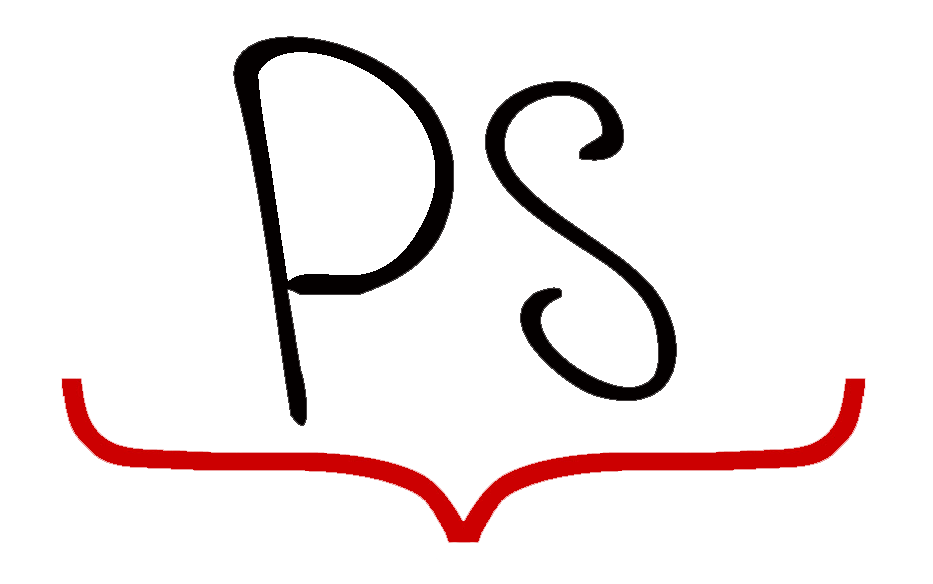Vincenzo Roberto Cassaro, Bologna –
Dopo aver analizzato la cura che il contadino medievale riversava sulla vite, in questo terzo – ed ultimo articolo – andremo ad osservare gli aspetti finali di questo lungo percorso.
Oggi come ieri, le operazioni di raccolta, vendemmia e vinificazione ricoprivano una grande importanza, sociale ed economica, per la vita delle comunità. È bene chiarire che non tutta l’uva era destinata alla vinificazione: una parte infatti, anche se minima, veniva consumata come frutta fresca da tavola e come uva passa. Un’altra piccola porzione, invece, serviva per la produzione dell’agresto, un condimento molto diffuso nella cucina medievale, che si formava aggiungendo del sale al succo dell’uva acerba. In sostanza, e con i giusti distinguo, si trattava di una sorta di aceto balsamico del Medioevo.
La vendemmia vera e propria era preceduta da alcune operazioni, necessarie alla manutenzione dei vasi vinari: botti, tini e recipienti di vario tipo dovevano essere bagnati, ripuliti e riparati. Le doghe e i cerchi usurati venivano sostituiti, mentre le eventuali muffe che si erano formate venivano eliminate con acqua e sale infine, si rinforzavano i cavalletti che sorreggevano le botti, le quali non poggiavano a terra per evitare l’umidità del suolo.
Per la costruzione dei vari recipienti era usato legname stagionato di alta qualità. In particolar modo, era preferito il legno di castagno e di rovere per le botti più grandi, in quanto si trattava di legni leggeri, elastici e allo stesso tempo compatti. Invece, per i recipienti più piccoli, si usavano soprattutto il legno di noce e l’abete, nei quali solitamente erano conservati i vini più robusti e pregiati. I cerchi servivano a tenere con maggior compattezza le doghe di legno. In molte zone erano costruiti da artigiani specializzati, i cerquarii, che preferivano adoperare soprattutto il castagno e il salice, mentre la loro saldatura avveniva attraverso i vimini; comunque potevano essere utilizzati anche cerchi in ferro, che erano più sicuri ma anche più costosi.

Per evitare perdite e infiltrazioni, tra i punti di connessione delle doghe era posta colla di farina di grano, pece oppure il sego, un particolare tipo di giunco di origine animale, in sostanza si trattava di grasso bovino o equino oppure ovino. Oltretutto, per rafforzare i recipienti, sul fondo degli stessi era collocato un asse di legno trasversale, mentre un’apertura circolare posta a metà altezza delle botti serviva a immettervi il vino. Per la costruzione e la riparazione di tini e botti si ricorreva a manodopera specializzata, i mastri bottai. Tuttavia, in caso di piccole manutenzioni, potevano intervenire gli stessi coltivatori. I mastri bottai erano responsabili del proprio operato, una responsabilità che si manifestava segnando il proprio marchio sulla botte una volta completato il lavoro. Comunque era pratica diffusa noleggiare tini e botti, indice che i costi della loro costruzione non erano trascurabili.
Dopo la maturazione dell’uva iniziavano le operazioni di raccolta, che potevano avvenire a mano oppure mediante l’uso di roncole, coltelli e forbici. I grappoli così raccolti erano messi in ceste di vimini, per poi essere travasati nei recipienti per la pigiatura. La vendemmia era una pratica di grande importanza per le comunità, sia in città che in campagna. Per favorirne le operazioni di raccolta e utilizzare più manodopera possibile, veniva sospesa, per la circostanza, l’attività ordinaria dei tribunali civili. Solitamente, la raccolta iniziava dalla data indicata negli statuti delle comunità o dopo il bando emesso dalle autorità locali, così da permettere al potere pubblico il controllo sulle operazioni, scoraggiare i furti ed evitare raccolte precoci (dettate dalla mancanza di vino oppure dalla paura che la vigna subisse dei danneggiamenti). Spesso, l’inizio della raccolta veniva fatta coincidere con il giorno di Santa Maria, l’8 di Settembre.
Nella fase di pigiatura erano adoperati dei tini oppure delle vasche. L’uso di quest’ultime era molto diffuso, specialmente nell’area laziale, dove venivano utilizzate in coppia: una vasca superiore, dalla quale il mosto poteva scorrere, grazie ad un’apertura circolare sul fondo, in una vasca inferiore, più piccola della prima, dalla quale a sua volta il liquido poteva essere raccolto esternamente da recipienti, pronto per essere travasato nei tini per la fermentazione. La pigiatura nei recipienti più piccoli avveniva solitamente mediante ammostatoi (dei lunghi bastoni in legno). In quelli più grandi, invece, l’uva era spesso schiacciata con i piedi e vi si poteva accedere tramite scale o impalcature. Spremitura e vinificazione potevano avvenire entrambe in vigna, al di fuori della stessa. Oppure, poteva capitare che la prima fase si svolgesse nel vigneto e la seconda lontano da quest’ultimo.

Nel caso della lavorazione in loco, era necessario che tra i filari ci fossero degli edifici adibiti allo scopo – anche se in Sicilia si attestano vasche a cielo aperto. Qualora né pigiatura né fermentazione si svolgessero nel vigneto, allora l’uva era trasportata verso i luoghi di trasformazione da carri, sui quali vi erano vari recipienti. Oppure da asini, sui quali si ponevano le bigonce da soma (secchi di legno). Nel caso in cui tra i filari avvenisse solo la spremitura, il mosto veniva trasportato (operazione molto delicata) nelle cantine castellane o cittadine, dove avveniva la fermentazione attraverso dei recipienti di forma allungata che a Bologna, in Romagna e nell’area veneta prendevano il nome di castellate. Ricordiamo che, dopo la pigiatura, il mosto poteva subire la torchiatura, una pratica poco diffusa in quanto i piccoli e medi proprietari difficilmente avevano le risorse economiche per costruire i torchi – che, in taluni casi, potevano raggiungere ampie dimensioni. Da questa operazione, inoltre, nasceva un vino di seconda (ma anche di terza o quarta) spremitura che era poco apprezzato.
La fermentazione poteva essere in “bianco”, di tradizione classica, nella quale il mosto era separato dalle vinacce, oppure poteva essere in “rosso”, nella quale mosto e vinacce venivano fermentati insieme: nel primo caso si otteneva un vino dal buon sapore, chiaro e puro; nel secondo, invece, si otteneva un vino dal sapore aspro e, a seconda delle uve usate, di color dorato, rubino o nero.
La fermentazione poteva avvenire con chiusura ermetica o a tino aperto, con continua mescolatura del mosto per evitare che le vinacce, rimanendo troppo in superficie, potessero rovinare il vino.
I tempi della vinificazione variavano in base ai luoghi e al tipo di prodotto: ad esempio, Piero de’ Crescenzi ci testimonia che nelle cantine bolognesi, la fermentazione in “rosso” durava circa 15 giorni. Una volta fermentato, il vino veniva versato nelle botti, attraverso grandi imbuti e secchi, per essere conservato; inoltre subito prima o dopo l’imbottamento il vino poteva subire delle lavorazioni particolari, pensiamo all’aggiunta di aromi.

Lasciando riposare le vinacce in acqua, invece, si otteneva l’“acquerello”. Si trattava di un mezzo vino consumato dagli strati sociali inferiori ma d’estate, se bevuto fresco, poteva trovare maggior apprezzamento. Pratica diffusa era versare sui resti della svinatura il vino di pessima qualità o mal conservato che, subendo una rifermentazione, era nuovamente bevibile: è quello che le fonti tardoantiche definiscono “vino acconciato”. Per ottenere invece un prodotto più robusto, il vino poteva essere riscaldato attraverso delle caldaie, determinando una riduzione di un quarto del prodotto iniziale. Da un ulteriore riscaldamento, fino ad una sua riduzione di tre quarti, si otteneva la sapa, un condimento molto dolce usato in cucina.
I vini più apprezzati nel Medioevo italiano, in base ai trattati agronomici tardomedievali, erano quelli giovani e dolci. Non è un caso che i trattatisti si creino il problema di come ringiovanire i vini e che quelli invecchiati fossero venduti a prezzi più bassi (anche l’invecchiamento di un anno poteva costituire un problema in quanto le caratteristiche di alcuni vini giovani potevano essere già alterate). Il sapore dolce, invece, dipendeva dal tipo di vitigno scelto e da alcune ricette o accorgimenti durante le lavorazioni: per esempio, una pratica era quella di tenere l’uva raccolta a riposo sul terreno, per alcuni giorni, prima di procedere alla pigiatura. Tra i vini più apprezzati vi erano i Moscati, soprattutto quelli liguri, le Vernacce delle Cinque Terre e i Trebbiani marchigiani, così come anche i vini “greci” del Mezzogiorno che, esportati in quantità nell’Italia centro-settentrionale, erano stimati per il loro sapore molto dolce e per la loro robustezza.
Fu solo a partire dal XV secolo che i vini verranno distinti anche in base alla qualità dei vitigni e/o ai luoghi di coltivazione. Prima, invece, venivano distinti unicamente tra “quelli di pianura” e di “collina”, nonché tra bianchi e rossi. Erano maggiormente amati i vini collinari, generalmente più robusti rispetto a quelli di pianura, e i bianchi, ritenuti più raffinati dei rossi. Quindi, non ci dobbiamo stupire se nel XV secolo i vini più cari erano quelli giovani, dolci, bianchi, di collina e magari provenienti da vitigni pregiati.
LE LETTURE CONSIGLIATE:
- A. Cortonesi-G. Pasquali-G. Piccinni, Uomini e campagne nell’Italia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2002