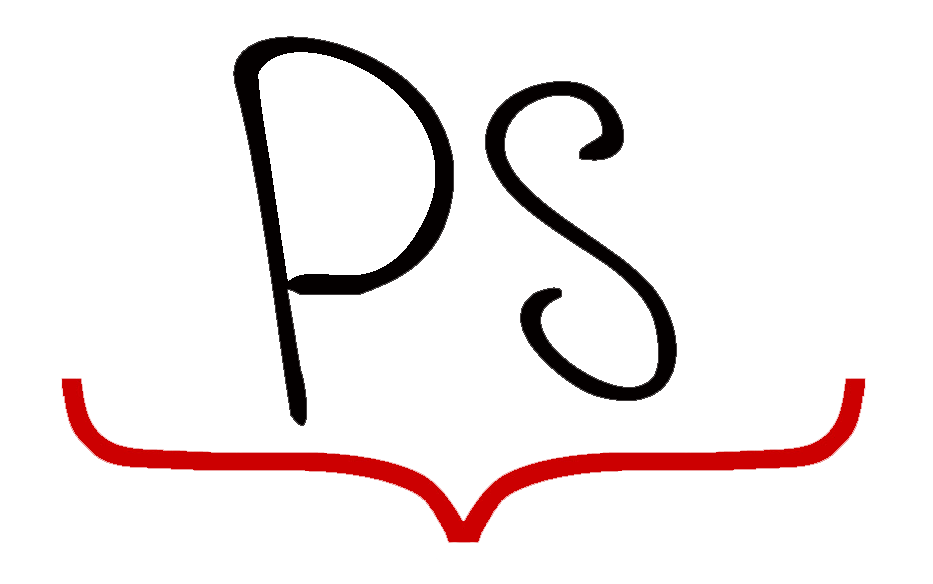Enrico Ruffino, Venezia –
C’è una data nel nostro personalissimo calendario civile che dovremmo cerchiare più marcatamente: il 30 giugno 1963. A Ciaculli, località palermitana nota per i suoi frutteti, in questa data esplodeva una Giulietta carica di tritolo uccidendo sette uomini delle forze dell’ordine. È la prima bomba della Repubblica, cui seguiranno altre, sempre più potenti e appariscenti, che via via, nel lungo e truculento corso della tristemente nota “prima Repubblica”, marcheranno la nazione nel segno del dolore.
E infatti, nella genesi di questa “Repubblica del dolore” (per citare Giovanni De Luna), Ciaculli non rappresenta solo il segnale di una mafia che muta forma, ma anche e soprattutto l’inizio di una pratica, quella della bomba, che avrà una escalation sempre maggiore: dai tre morti “accidentali” di Ciaculli, allo scempio dei civili di sette anni dopo, per approdare alla devastazione di Bologna e infine ritornare alle auto che saltano in aria del ’92. Eppure quando Ciaculli scoppiò, qualcuno, dalle parti del profondo Nord, non tardò a ribadire che “questi siciliani sono pazzi!” e qualche altro, impaurito dell’accaduto, disse persino “vuoi vedere che questi vengono a mettere le autobombe pure qua?”.

La migrazione degli anni ’60, genesi di ogni pregiudizio verso il sud, in effetti faceva paura ma, per sfortuna e per fortuna, giunse l’operazione Piazza Fontana a far comprendere che il problema “bombe” in realtà era tutt’altro che siciliano. La pratica bombarola è infatti un’arma di pressione psicologica e Cavataio, l’ideatore dell’operazione, lo sapeva benissimo: si era messo in mezzo, con una sofisticata operazione, nella guerra tra i Greco e i costruttori La Barbera e la bomba doveva servire per esacerbare gli animi (direbbero i siciliani: per mettere zizzania) e goderne dei frutti successivi. Sei anni dopo giunsero i corleonesi, nel frattempo inseritisi sì come terza parte, a mettere fine ai giochi dell’intraprendente Cavataio con un agguato nel suo ufficio di Viale Lazio degno dei maggior sceneggiati televisivi. Era il 10 dicembre 1969, due giorni dopo una bomba nella sede della banca nazionale dell’agricoltura avrebbe fatto scempio di innocenti.
C’è un legame tra Ciaculli e Piazza Fontana? Entrambe rappresentano dei momenti di svolta: per la mafia – che muta forma, assume dimensioni internazionali, lucra sul nuovo e imponente business della droga, comincia a mutare la sua struttura – e per la Sicilia – i cui repentini cambiamenti politici nazionali influiscono pesantemente nella nuova riorganizzazione di quelli regionali – e per la conflittualità “politica” italiana, che da Piazza Fontana diventa esacerbante. Momenti di svolta, certo, ma è ancora una volta la Sicilia che anticipa le tecniche, che si fa metafora, nel senso più sciasciano del termine: Piazza Fontana come Ciaculli, segni di un cambiamento imponente e di una conflittualità che si preannuncia infinitamente violenta. Segni di un clima “caldo”.
Ricordare nel nostro calendario civile Ciaculli significa quindi prendere atto, come sostiene nel suo ultimo libro Piero Melati (Giorni di Mafia, Laterza 2017) che
…molti nodi irrisolti dell’attualità italiana provengono dalla Sicilia, oppure è nell’isola che sono diventati estremi ed evidenti: l’omicidio come strumento di pressione, il traffico internazionale di droga, la corruzione elevata a sistema, le speculazioni urbanistiche, il rapporto conflittuale tra magistratura e politica, le lotte intestine tra apparati dello Stato, l’uso criminale dell’economia e della finanza, i grandi ricatti, il ruolo delle sette segrete, la gestione spericolata e senza regole del potere, il voto di scambio, l’uso spregiudicato dei media, il valore civile dei prodotti culturali, il ruolo degli intellettuali, il peso degli equilibri internazionali.
Ma non solo Ciaculli. Serve prendere atto che questi “nodi” – come li chiama Melati – hanno radici più o meno antiche che si generano dal seme della Repubblica: non è un caso che il suo libro inizi con il 5 luglio 1950, l’assassinio del bandito Salvatore Giuliano, perché è lì, in quella “tenebrosa” vicenda – in cui la matassa dei network mafiosi si annoda nei meandri della politica siciliana e muta in favore di una più interessante commistione col partito di governo piuttosto che con l’ingombrante fardello del separatismo – che si alimentano i segni di un anticomunismo che verrà assurto a male di ogni dramma italiano, anche quando i drammi si sviluppano in altri contesti e con altre esigenze. Anche in quel caso la Sicilia diventa metafora o – piuttosto – premonizione di ciò che avverrà in futuro: come in un processo che dal particolare arriva a principi generali, anche i drammi siciliani sono metafora dei drammi italiani.

E così un giorno qualche storico dotato di particolare guizzo interpretativo potrà utilizzare la Sicilia come paradigma indiziario per capire gli sviluppi dell’Italia repubblicana: il processo Giuliano che diventa “spettacolo”, in cui la suspence è delineata dall’attesa di una rivelazione – l’unica, grande rivelazione, il nome del “colpevole”, ma soprattutto quel nome, laddove il pronome è sinonimo di impronunciabilità – e il processo al nucleo storico delle BR, che diventa anch’esso palco di una grande messinscena, tutta tesa a demolire l’essenza stessa del ruolo arbitrario dello Stato: il processo. Sullo sfondo – sia di Giuliano che delle BR – ci sono le simpatie di una popolazione e di alcune classi sociali mentre nei sotterranei della farsa le guerre intestine: quelle interne di potere, gli occhiolini di chi si è tolto i capi ingombranti dalle scatole e di chi invece rimpiange la “vecchia guardia” a dispetto della nuova.
D’altronde se volessimo andare più in là in questo lungo viaggio tra le metafore ci accorgeremmo che piano piano ci si avvicina all’Italia propriamente detta e ci si accorge che la Sicilia, da isola tutta contrita in se stessa, diventa Italia tout court: vicende tutte siciliane che approdano sul palco della nazione; Il giorno della civetta che diventa film, il pasticciaccio brutto del Caravaggio rubato, la scomparsa di De Mauro che diventa un thriller internazionale sulla fine di Mattei, quest’ultimo che approda addirittura a Cannes dominandone la scena, l’omicidio Impastato che cozza con il ritrovamento del funerale della Repubblica moroteo e via via più là nei meandri di una mafia che sempre più diventa italiana e per venire ai giorni nostri dominatrice del libero mercato. In mezzo le scie di sangue, ricordate dalla mente di chi ne ha viste troppe, ma mai violentemente evocate.

Piero Melati
Melati infatti ha deciso, almeno per questa volta, di abbandonare la retorica del testimone e di assumere invece quella più complicata dello stimolatore di memorie, di colui che sì ha vissuto le vicende ( non tutte, a dire la verità) ma vuole lasciare quest’esperienza tra le righe, nascosta tra le parole, consapevole che questo paese ha bisogno di deporre le penne, di terminare la “guerra civile di carta”, per cominciare ad orientarsi nei meandri di traumi profondi che possono essere compresi solo se si ha il coraggio di mettere da parte le proprie storie ( e non la propria memoria), in modo da fermarsi per lasciarsi andare ad un esame di coscienza collettivo. Chi volesse meglio capire questa prospettiva dovrebbe leggere una piccola ma emblematica frase di pagina 101 in riferimento alla figura del Generale Mori:
Dopo la strage di Capaci i politici si nascosero tutti sotto le scrivanie. Se ne deduce: qualcuno doveva sporcarsi le mani. Allora a chi l’ardua sentenza? Se alla fine non si potranno individuare reati, diremo che l’uomo è troppo complesso per un’aula giudiziaria.
Apriti cielo. Ci voleva l’arguzia e il coraggio intellettuale di Melati per dire che un dibattito serio su Mori e le vicende che ha attraversato in quarant’anni di vita investigativa (e non scordiamolo: di intelligence!) avrebbero bisogno di una seria analisi storica, poiché la storia non è tesa a giudicare – come lo è invece la giurisprudenza – ma a comprendere! E c’è di più: non possiamo lasciare le vicende che attorniarono Capaci e Via D’Amelio alle dispute tra avvocati e procure, tra vecchie e nuove ruggini, ma abbiamo bisogno di deporre le armi, riflettere sulla dimensione di quel fatidico ’92 culmine di un processo davvero complesso di mutazione diremmo “genetica” del network mafioso, e unirci in uno sforzo di analisi e memoria che vada oltre le guerre di carta, tutte intrise di deposizioni e verbali (scrisse Salvatore Lupo, in risposta ad un’interpretazione di Sciascia, che le fonti giudiziarie sono quanto di più intenzionale ci possa essere) ottime per chi volesse stabilire le verità giudiziarie ma limitanti e pericolose per chi si accingesse a stabilire le verità storiche. Abbiamo bisogno quindi di una vera e propria “agenda della memoria”: di aprirla ogni giorno per controllare quali e quante sono le cose da ricordare, per poi orientarci tra i morti, tra le loro eredità, tra i loro simboli e i loro significati. Giorni di mafia è un libro che va letto così, un giorno alla volta, per cento giorni: solo imparando ad orientarci, a dare alla nostra memoria un significato corretto, potremmo ristabilire la tanto agognata verità.