
A cura di
Enrico Ruffino,
Alessandro Rigo –
Parentesi Storiche ha incontrato Carlo Ginzburg lo scorso giugno, alla fine di una conferenza all’Università di Verona. Un po’ emozionati ci siamo appropinquati, tra la massa di dottorandi e docenti di ogni disciplina umanistica, a chiedere “se fosse possibile farle qualche domanda”. Ginzburg era di fretta, attorniato dalla miriade di persone che si avvicinavano per tendergli la mano, e aveva appena terminato una conferenza di quasi due ore su “una ricerca abbozzata”, in fieri su Ernesto De Martino e i momenti della ricerca. Nonostante questo si è reso disponibile ad interloquire con noi. Ci tocca, però, avvertire il lettore che non troverà una intervista tout court, approfondita nei minimi dettagli come Parentesi è solita fare, ma un colloquio breve, succinto ma incisivo, su alcune questioni che possono apparire certamente “banali” ma per noi emblematiche di tendenze e discussioni facilmente fraintendibili, dalla quale abbiamo estrapolato dei temi su cui riflettere.
- Storie di microstoria
Abbiamo chiesto, ad esempio, se lo storico condividesse i giudizi che gli autori del Manifesto per la storia danno sulla microstoria e la sua evoluzione, essendo ben consapevoli del suo dissenso. Cercavamo di capire infatti le motivazioni: e Ginzburg a questo proposito, sebbene di fretta e succintamente, ci ha detto che l’argomentazione non è di “alcun interesse” perché “sono i risultati quelli che contano”. “La microstoria è un’etichetta che raggruppa ricerche di qualità e impianti diversissimi” e registra, a proposito del fatto che lo sguardo microstorico non possa più essere rispondente all’esigenze del presente, che “esiste un’associazione di studiosi che si richiamano alla microstoria, che rispondono in rete, diretta da uno storico ungherese e da uno storico islandese”.
Il fatto, pertanto, gli appare “già di per sé significativo”. Si dovrebbe aprire un’intera pagina di storiografia per spiegare questo pensiero. Si dovrebbe spiegare perché “l’etichetta” non ha senso riconoscendo quando, dove e perché la riduzione di scala nell’osservazione avviene. Qui basterà citare l’altro grande “esponente” del pensiero microstorico, Giovanni Levi, che nel ’93, intervenendo in volume collettaneo a cura di Peter Burke sulla storiografia contemporanea, sosteneva che “non esiste un’ortodossia microstorica come in genere non si può proporre una ortodossia di un lavoro fortemente sperimentale. E la diversità dei prodotti mostra immediatamente che gli elementi in comune sono pochi- per quanto a mio avviso essenziali”. “Impianti e qualità diversissime” dunque: perché la microstoria non è uno statuto epistemologico, non è un elemento teorizzato e universalmente valido, è uno dei possibili modi di fare storia. È una “pratica”, una continua sperimentazione, come sostiene Levi. Fatichiamo però a condividere l’affermazione di Giovanni Levi secondo la quale “alcuni caratteri distintivi sono legati al dibattito culturale e politico nel corso degli anni Settanta” ma che questi non abbiano una peculiarità italiana perché “gli anni settanta e ottanta sono stati praticamente ovunque anni di crisi della ottimistica immagine di una trasformazione radicale del mondo secondo le linee rivoluzionarie e in tempi brevi”.

Giovanni Levi
A questo proposito abbiamo chiesto a Ginzburg se il suo saggio sul “paradigma indiziario” fosse (anche) dettato dalla situazione italiana del periodo, ovvero dalla ricerca di nuovi metodi per accedere ad una realtà che, soprattutto in quel frangente, appariva “opaca”. Ginzburg ha risposto affermativamente ritenendo il nostro ragionamento “interessante”, ricordando un seminario a Bologna, nel ’77, con i suoi studenti in cui “questo elemento era presente”. D’altronde si è tra il ’77 e il ’79, il periodo che segna la fine dei “movimenti”, marca l’Italia di una scia di violenza inaudita e si trova a fare i conti coi “misteri”, i “non detti”, entità che si aggirano per l’Italia come fantasmi senza aver né un volto né un nome. Com’è andato il sequestro Moro? Chi ha agito? Sono state in tutto e per tutto le Brigate Rosse? Sono domande che ci portiamo dietro ancora oggi senza saperne granché. Nello stesso anno in cui comparirà il saggio sul paradigma indiziario e la discussione sulla microstoria prenderà piede, il ’79, Alessandro Portelli pubblicherà su Primo Maggio un pioneristico saggio sulla storia orale che s’imporrà come “linea-guida” dell’impostazione dell’odierna storia orale. Dall’Italia alla storiografia mondiale. Non sono peculiarità? Un problema aperto.
Tuttavia è bene ricordare che i “microstorici” – tra cui, oltre allo stesso Ginzburg e Giovanni Levi, anche e soprattutto Edoardo Grendi – vengono da biografie e formazioni diversissime, anche geograficamente. Si potrebbe ricordare la comune radice “ebraica” di Ginzburg e Levi, le cui parentele si amalgamano con quelle di altri, importanti intellettuali come Primo e Carlo Levi. Radici che tuttavia non influiscono minimamente sulla loro concezione del fare storia. Levi, ad esempio, ha studiato nella proficua Torino degli anni ’50 ed Edoardo Grendi tra Genova e l’Inghilterra affrontando temi assai diversi da quelli dei colleghi. Si tratta piuttosto di un continuo influsso e reflusso di una discussione che avviene tra intellettuali senza alcun legame confessionale, con storie e interessi di ricerca variegati, in cui influiscono non solo le discussioni e innovazione esterne (e le maggiori “importazioni” avvengono per mano di Grendi) ma anche il confronto con intellettuali di altri ambiti disciplinari: in Microstoria. Due o tre cose che so di lei Ginzburg ricorda, ad esempio, che la prima volta che sentì parlare di microstoria fu per mano (e per penna) di Primo Levi, il quale nel Sistema Periodico usò questa espressione; e non possiamo ignorare nemmeno il progetto abortito di una rivista con Italo Calvino intorno al ’72, nella quale, come progetto iniziale, ci si proponeva come osservatori della realtà attraverso lo “sguardo dell’archeologo”, ovvero di intellettuali che (ri)cercavano attraverso i “cocci” di (ri)comporre storie più complesse, per le quali i vecchi statuti epistemologici non erano più sufficienti.
- Tra famiglia, formazione e incontri nella ricerca
Ginzburg, è noto, proviene da una famiglia di intellettuali. Il padre, Leone, fu uno dei più importanti filologici di slavistica del primo novecento e la madre, Natalia, una delle più importanti scrittrici dell’Italia repubblicana. A tal proposito è utile ricordare un’intervista del ’76 che Ginzburg rilasciò ai microfoni dell’allora responsabile nazionale della sezione cultura del movimento studentesco, Giorgio Politi (oggi ordinario di storia moderna all’Università Ca’Foscari) pubblicata all’interno della rivista “Realismo“. Nell’intervista-saggio Ginzburg riflette, a domanda, sulla sua formazione, ammettendo che in realtà il suo accesso alla cultura fu facilitato dall’ambiente familiare (e anche l’accesso – bisogna dirlo – all’editoria dato che la madre era una dirigente dell’Einaudi e il padre ne fu fondatore). Tuttavia gli influssi familiari possono essere un utile trampolino di lancio ma non bastano per diventare “storici”, serve una formazione, dei “maestri” da cui recepire e assimilare le lezioni per poi tradurle in pratiche storiografiche. Alla Normale di Pisa, in un periodo in cui dall’Istituto pisano passarono i più importanti storici della contemporaneità, Ginzburg incontrò Delio Cantimori i cui influssi e le cui lezioni influirono pesantemente nei suoi saggi successivi: se non altro perché è possibile rintracciare le premesse alla discussione sulla “cultura popolare” fin dagli eretici di Cantimori, in cui – ad avviso di chi scrive – non è azzardato rintracciare anche i prodromi del Formaggio e i Vermi.
Più che il famoso testo di Ginzburg, preambolo della microstoria, appare palese invece un influsso cantimoriano nei Benandanti e – neanche a dirlo – nel saggio sul Nicodemismo che da una felice intuizione del maestro prendeva spunto. Un saggio ferocemente criticato da alcuni esponenti della comunità storiografica ma che in realtà non fu mai pienamente capito. Ritornando ai Benandanti però è utile ricordare che Ginzburg si impreziosì delle letture dell’Istituto De Martino al quale ebbe accesso sotto consiglio di Cantimori stesso. E’ lì che avvenne l’incontro con l’antropologo napoletano e fu un idillio che dura tutt’ora. Sul concetto di “cultura popolare” si potrebbe scrivere un saggio intero. Qui basterà ricordare che nel periodo in cui Ginzburg riflette su questo concetto la discussione è animata da un interesse spasmodico, ora proficuo ora inconcludente laddove assunse caratteri prettamente ideologici, verso le manifestazioni folkloriche e nei riguardi degli “emarginati”, degli “esclusi” o – citando Fanon – dei “dannati della terra”. Certo, la de-colonizzazione aveva portato a riflettere su quegli individui che non erano entrati nei discorsi pubblici occidentali, sull’eredità che un recente passato coloniale aveva portato in grembo e che adesso entrava con tutta la sua potenza nei temi e negli interessi dell’attualità.
Negli anni ’60, d’altronde, iniziavano a comporsi “movimenti sociali” i cui temi e sviluppi prendevano spunto da questi incessanti elementi. Restando in Normale, ad esempio, appare emblematico che un pioniere del movimento pacifista, quale fu Aldo Capitini, fosse insieme uno dei docenti più apprezzati e un intellettuale che portava alle spalle una storia di dissenso nei confronti del regime fascista culminata nel gran rifiuto del giuramento. Avanti e indietro le contaminazioni con un recente passato e un presente impellente si amalgamavano fino a comporre una galassia, tanto culturale quanto sociale, composita. E il fulcro, oramai, era focalizzato sugli emarginati, sugli esclusi o, per meglio dire, sui “ceti bassi” che la “storia politica” aveva emarginato. Non si tratta di una discussione italiana. Anzi la discussione prese piede proprio nei paesi ex colonizzatori: tant’è che l’impatto dei “sistemi di pensiero” di Foucault suscitò entusiasmi e dinieghi, come quello di Carlo Ginzburg.
Nell’introduzione al Formaggio e i vermi (’76) – saggio in cui lo storico tracciava le line guida del suo approccio alla cultura popolare facendo intravedere i prodromi della microstoria – Ginzburg decise di criticare fortemente il filosofo francese con una stoccata che a molti sarebbe apparsa come una sorta di “ostracizzazione” del pensiero foucaltiano dagli studi storici: “Foucault è talmente interessato al discorso sull’emarginazione che si è dimenticato degli emarginati”. In realtà Ginzburg non intendeva “ostracizzare” nessuno e il giudizio, sebbene tranciante, appariva come l’inizio di una “battaglia” che lo storico italiano avrebbe combattuto negli anni ’80 contro quelle che lui definì le “derive irrazionaliste”: a partire da un discorso complesso all’interno della c.d. “svolta linguistica”, Ginzburg si trovò a discutere animatamente con lo storico della letteratura Hayden White vedendo nella sua tesi – secondo la quale sia la storia che il romanzo viaggiavano sulla stessa linea d’aria, ovvero quella linguistica – una pericolosa deriva. Il fulcro era naturalmente il concetto di “prova” che sia White sia Foucault negavano in quanto derivazione linguistica: se la storia è solo un discorso linguistico, se è finzione, allora dovremmo dire che la Shoah non è mai esistita? Invece lo diciamo perché abbiamo le prove per poter dire che la realtà è stata quella, senza le prove la realtà si dissolve. In soldoni l’argomentazione di Ginzburg.
Molti anni dopo, lo storico italiano avrebbe ribadito il suo “no” alla filosofia foucaltiana sostenendo che “il problema non è dimenticare Foucault, ma utilizzarlo” invitando a non guardare la sua filosofia come un elemento intellettuale da scartare interamente: “Penso che Foucault abbia fatto tutto il possibile per non essere utilizzato in maniera critica. In gran parte c’è riuscito, ma forse è possibile riaprire la partita. Tra le cose che certamente vanno usate c’è la metafora della microfisica del potere. Foucault non l’ha sviluppata, ma altri potrebbero farlo in una prospettiva analitica”. Un’apertura? C’è che in realtà, il discorso sugli emarginati, e quindi anche sulla cultura popolare, diventa, a partire dagli anni ’60, un discorso dominante che interessa non solo gli storici – quelli più giovani e rampanti – ma anche e soprattutto i movimenti da cui Ginzburg non è totalmente esente. Grande amico di Adriano Sofri, a cui dedicò persino un saggio, non era poi così distaccato da Lotta Continua come si potrebbe sembrare. Nell’intervista a Politi tenderà a ribadire di aver rimpianto di non essere mai stato un “militante” e crediamo che il rimpianto sia dovuto soprattutto all’amicizia che lo legava all’ex esponente di spicco della formazione operaista. De Martino, in quello scorcio di anni ’60, cadde a fagiuolo e suscitò gli interessi di una storiografia e insieme di un’antropologia restii ad apprezzarlo in vita. L’oggetto della conferenza a cui Parentesi ha avuto l’onore di assistere parte proprio da quell’incontro: che cosa significa auto-immedesimazione?
- Filologia, auto-immedesimazione e distanza
E’ – secondo Ginzburg – una proiezione, un elemento umanamente impossibile. Significa entrare in quello che non si è, lasciare alle spalle la propria cultura per immedesimarsi in un’altra. Un’utopia perché l’uomo non potrà scrollarsi di dosso gli abiti della propria cultura, della propria crescita in un determinato luogo da cui antropologicamente è stato influenzato. Allora, come ottemperare a questo deficit? Con la filologia, con lo studio scientifico della parola: “invece di riversare le proprie aspettative negli altri bisogna cercare di capire le lingue altrui”, afferma ai nostri microfoni e in ciò c’è tutto quello che De Martino ha insegnato con la sua – inizialmente sfortunata – opera. Ma non solo: c’è anche molto di Cantimori in ciò. Lo storico romagnolo ha infatti trovato, nella sua forsennata e contorta ricerca di libertà, nella filologia uno strumento utile non solo a “comprendere indagando” (di Droyseniana memoria) ma anche e soprattutto un mezzo per accedere alla libertà. Solo con lo studio scientifico, corretto e pedissequo è possibile rinnovarsi, pensarsi criticamente e mettere in discussione i dogmi. Non a caso la grande ammirazione (che non significa infatuazione) per gli eretici andava di pari passo con quella per Lutero. Con ciò non si intende affermare che la complessità dell’opera di Ginzburg vada ricercata nella sola produzione di Cantimori, come un semplice passaggio di testimone da maestro ad allievo, ma s’intende semplicemente ribadire che gli stimoli sono giunti anche da lì (e ricordiamo: fu Cantimori stesso che lo indirizzo verso l’Istituto Warburg). Se infatti gli è stato possibile scrivere un saggio sulla distanza (Occhiacci di Legno, Feltrinelli) lo si deve non solo alla ricezione da altri studiosi (Calvino, caro amico di Ginzburg, scrivendo la sua prefazione a Se una notte un viaggiatore disse di voler far passare il messaggio che un libro è frutto di altri libri) ma anche e soprattutto alla distanza, allo “spaesamento”, in cui si trovò quando andò ad insegnare negli Stati Uniti: con degli alunni lontanissimi dalla sua, dalla nostra formazione culturale e di etnie variegate, iniziò a comprendere – come ebbe a dire nell’introduzione al libro – quanto la distanza fosse importante per l’uomo. Una chiosa che è possibile riassumere in una delle sue più belle frasi:
Tutto il mondo è paese non vuol dire che tutto è uguale: vuol dire che tutti siamo spaesati rispetto a qualcuno e a qualcosa.
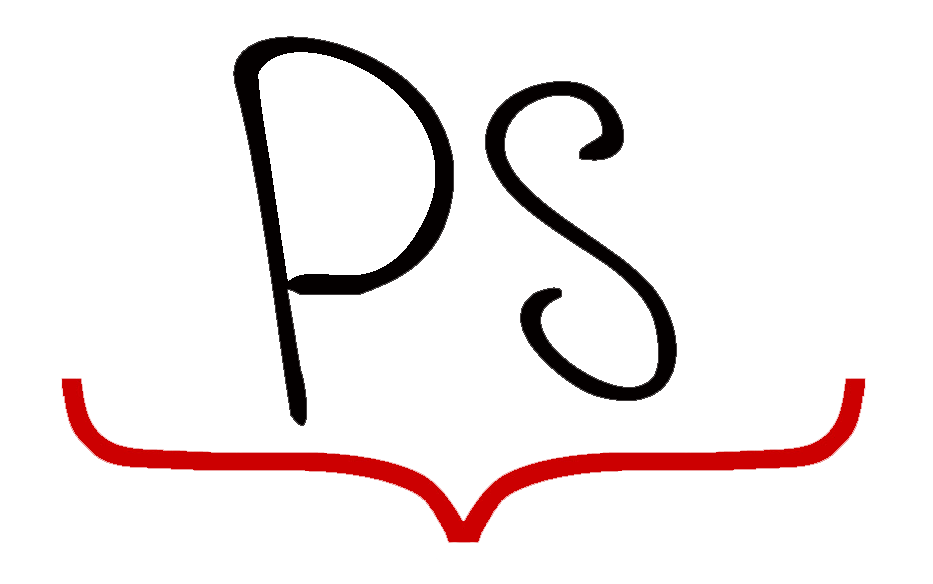


Discsussione utilissima che condivido in gran parte