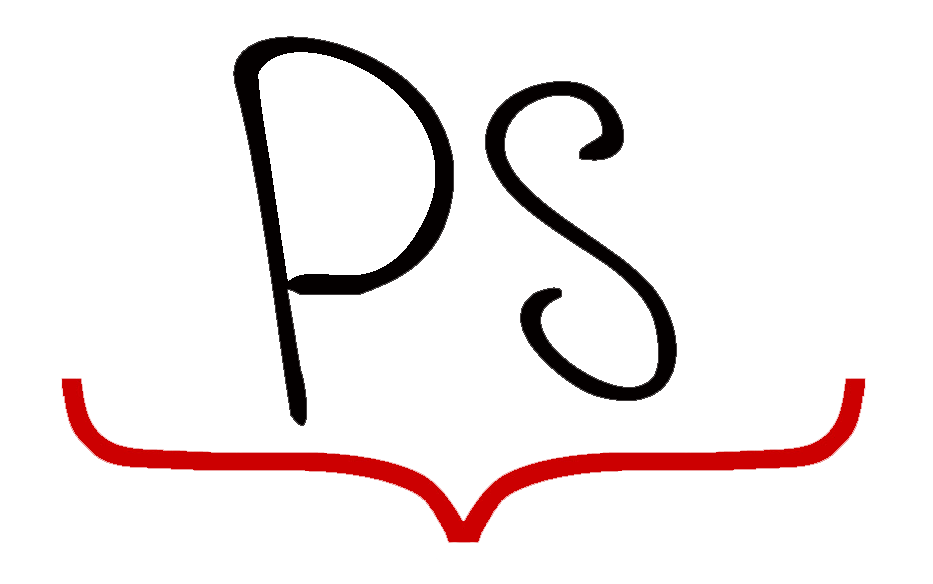Francesco Fontana, Verona –
Il 16 marzo 1978, poco prima delle nove del mattino, Aldo Moro sale a bordo di una Fiat 130, sotto la sua abitazione di via del Forte Trionfale, a Roma. Seguito dall’alfetta di scorta, si sta recando alla Camera, dove i deputati voteranno la fiducia al nuovo governo di unità nazionale, il primo sostenuto da un accordo elaborato anche dal Pci.
Il sostenitore principale dell’apertura a sinistra è proprio Aldo Moro. In via Fani una Fiat 128 li precede, si ferma allo stop, blocca la strada. Un commando terrorista apre il fuoco sulla scorta, uccide i cinque agenti e carica il Presidente illeso su una Fiat 132 che si dilegua, scortata da altre auto.
Iniziano i cinquantacinque giorni di prigionia, conclusi con il ritrovamento del corpo senza vita dell’Onorevole nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in Via Caetani.
Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro sono argomenti controversi da trattare, ricchi di tasselli mancanti e di enigmi ancora irrisolti. L’intera vicenda è un mistero italiano. Sono tre i film che, da prospettive molto diverse, se ne sono occupati: Il caso Moro (1980) di Giuseppe Ferrara, Piazza delle cinque lune (2003) di Renzo Martinelli e Buongiorno, notte (2003) di Marco Bellocchio.
Il caso Moro (1980)
Quello di Ferrara è un film girato “a caldo”, dal quale tuttavia emerge l’ipotesi della regia occulta, orchestrata dai servizi segreti, che ha caratterizzato il rapimento e il tragico epilogo. Il protagonista è interpretato da Gian Maria Volonté, icona delle pellicole di impegno politico-civile anni Settanta, perfettamente calato nella parte e molto somigliante all’originale.
Prima della ricostruzione della strage, il regista propone un suggestivo montaggio alternato: Moro è nella sua casa, la scorta lo attende e i brigatisti si preparano ad entrare in azione. Si passa poi agli incontri al Viminale, per mostrare da subito dove si “gioca” la vera partita e dove si decidono le sorti del Presidente. Alle riunioni partecipano gli esponenti politici e un consulente, giunto appositamente da Washington.
Si getta ben più che un’ombra sul mondo delle istituzioni, che vogliono fare emergere la loro verità, cercando di fare apparire le richieste di aiuto di Moro – espresse nelle lettere – come estorte o, comunque, non attribuibili a lui. Le due figure centrali sono quelle di Giulio Andreotti (Daniele Dublino), presentato come un freddo calcolatore interessato prioritariamente alle sorti del governo, e di Benigno Zaccagnini (Bruno Corazzari), amico del Presidente, che appare sconvolto, orientato a cercare la salvezza dell’uomo prima di tutto.

Nel contempo, nella “prigione del popolo” il Moro di Volonté appare risoluto, instaura un dialogo con i brigatisti, centrato prioritariamente su tematiche politiche, credendo nelle possibilità di salvezza, poi deluse dall’immobilismo della classe politica.
Le immagini dell’uccisione del Presidente, crivellato da colpi di mitra nel bagagliaio della Renault 4, sono alternate proprio a quelle dell’incontro nella sede della Democrazia Cristiana, dove si ammette il fallimento politico; una connessione cruda ed esplicita: si punta il dito verso quelli che sono ritenuti complici, se non unici responsabili.
Dopo alcune immagini documentaristiche di una via Caetani affollata attorno all’auto con il corpo del Presidente, torna la voce di Volonté che, con grande fermezza, raccoglie in un’espressione il messaggio del film, dicendo:
“Per una evidente incompatibilità, chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito solo dai pochi che mi hanno veramente voluto bene”.
Piazza delle Cinque Lune (2003)
Se Ferrara percorre la strada del racconto della regia occulta dietro al rapimento di Moro, Martinelli con Piazza delle cinque lune mette in scena una pellicola complottistica, basata su minuziose ricostruzioni che trovano riferimento nel libro di Sergio Flamigni, La tela del ragno.
Il film si apre a Siena, da una prima panoramica dall’alto si scende in picchiata fino in Piazza del Campo, metafora che esprime la necessità di studiare i fatti dalle fondamenta, prima di poterne avere una visione più completa.
Il procuratore capo di Siena appena pensionato Rosario Saracini (Donald Sutherland) sta facendo rientro a casa e viene aggredito nell’androne del suo palazzo da un uomo che lascia cadere a terra una pellicola.
Saracini, scosso, rientra e la inserisce nel proiettore, sono le immagini del rapimento di Aldo Moro: manca però il tamponamento e molti altri aspetti della ricostruzione ufficiale dei fatti si presentano in modo diverso. Il giorno seguente, nella cerimonia di congedo, il procuratore afferma:
“Nell’appassionata ricerca della verità, nell’evocazione e nella diffusione della verità risiede il segreto della vita”.
Questa diventa la sua missione.
Le indagini procedono per tappe, che sono esplicitate in una delle sequenze conclusive, dal valore metaforico, in cui Saracini, con i suoi collaboratori interpretati da Stefania Rocca e Giancarlo Giannini, sale i diversi piani della Torre del Mangia. Si fermano dopo qualche gradino: è la prima tappa, nella quale hanno capito che il sequestro era decisamente anomalo. Salgono ancora, da lì hanno scoperto che anche il covo di via Gradoli era improbabile.

Poi sono a tre quarti della torre, da dove hanno stabilito che anche Moretti era una capo terrorista poco credibile. Poi si giunge in alto, sulla vetta, dove Saracini comunica di aver incontrato un personaggio detto “Entità”, che gli ha parlato di Hyperion, stazione CIA con l’obiettivo di impedire l’ingresso del Partito comunista al potere in Europa occidentale. Siamo alla conclusione delle indagini, il percorso verso la verità è quasi terminato.
Nel finale l’ex procuratore è convocato a Roma, quando giunge sul posto però ad attenderlo c’è anche la fidata scorta Branco (Giancarlo Giannini), che gli confessa il tradimento, dicendo di essere stato coinvolto da eventi più grandi di lui.
La cinepresa riprende Saracini di spalle, poi esce dalla stanza e sale vorticosamente le scale del palazzo sfondando il tetto e offrendo una panoramica dall’alto di Roma che, in dissolvenza incrociata, diventa una ragnatela; dissolve in nero e compare la frase di Solone:
“La giustizia è come una tela di ragno: trattiene gli insetti più piccoli, mentre i grandi trafiggono la tela e restano liberi”
Espressione emblema della lettura di Martinelli.
Buongiorno, notte (2003)
Buongiorno, notte, si discosta in modo evidente dalle altre due pellicole, offrendo una prospettiva borderline, che propone i brigatisti vivere empaticamente il rapporto con il loro prigioniero.
Il film inizia con la visita di un appartamento, in via Montalcini, al numero 8, da parte di una giovane coppia interessata all’acquisto: i due brigatisti Chiara (Maya Sansa) ed Ernesto (Pier Giorgio Bellocchio), ispirati alle figure di Anna Laura Braghetti e Germano Maccari.
Nella sequenza di apertura gli sguardi dei due sono immobili, il loro incedere meccanico, prigionieri di quella gabbia che si palesa nelle sbarre disegnate sulla parete dalla luce del sole che attraversa le veneziane. È l’inizio di un film in soggettiva: lo spettatore vive tutto tramite lo sguardo e i sogni di Chiara, brigatista anomala, che desidera la fuga del suo prigioniero e immagina un rapporto quasi filiale con Aldo Moro (Roberto Herlitzka), manifestato nel bisogno ossessivo di spiarlo dallo spioncino.
La stessa Anna Laura Braghetti nella sua autobiografia scrive:
“Lo spiavo ogni sera, come per capacitarmi che fosse davvero lì, in casa mia, mentre tutti lo cercavano, mentre il mondo intero parlava del sequestro, faceva congetture su di noi, ci malediceva, ci dava la caccia”
(Anna Laura Braghetti, Paola Tavella Il prigioniero, p. 173).
Non c’è la violenza di via Fani, è un film concentrato su possibilità diverse, in uno scontro continuo tra realtà e immaginazione. A viverlo è Chiara, che esulta alla riuscita del rapimento, ma poi viene riportata all’ordine da un suono extradiegetico, quasi punitivo, assordante.

In un sogno la ragazza prende addirittura per mano il prigioniero per accompagnarlo alla porta, in un altro, invece, incontra il suo sguardo paterno, che sembra chiedere alla figlia ribelle: “Cosa stai facendo?”.
Tutto però si condensa nella sequenza finale. Troviamo anche qui una situazione onirica, “violentata” però dall’intromissione della realtà: nei sogni di Chiara il prigioniero, sorridente, esce passeggiando all’alba per le strade di Roma.
Irrompono i fatti: i tre brigatisti aiutano Moro a uscire dalla “prigione del popolo”, lo stanno portando a morire. Ma Bellocchio non vuole concludere così, allora ritorna a mostrarci un’immagine surreale quanto rassicurante del Presidente che passeggia sereno per la Capitale deserta.
La motivazione della scelta è tutta nelle parole del regista:
“Non potevo subire la tragedia di venticinque anni prima, non potevo accettare quella fatalità religiosa. Dovevo tradirla, dovevo ribellarmi a quella cronaca inerte, indifferente, disperata”
(Christian Uva, Schermi di Piombo: il terrorismo nel cinema italiano, p. 74).
LE LETTURE CONSIGLIATE:
- S. Flamigni, La tela del ragno, Milano, Kaos, 2003
- A. L. Braghetti-P. Tavella, Il prigioniero, Milano, Feltrinelli, 2003
- C. Uva, Schermi di Piombo: il terrorismo nel cinema italiano, Catanzaro, Rubbettino, 2007