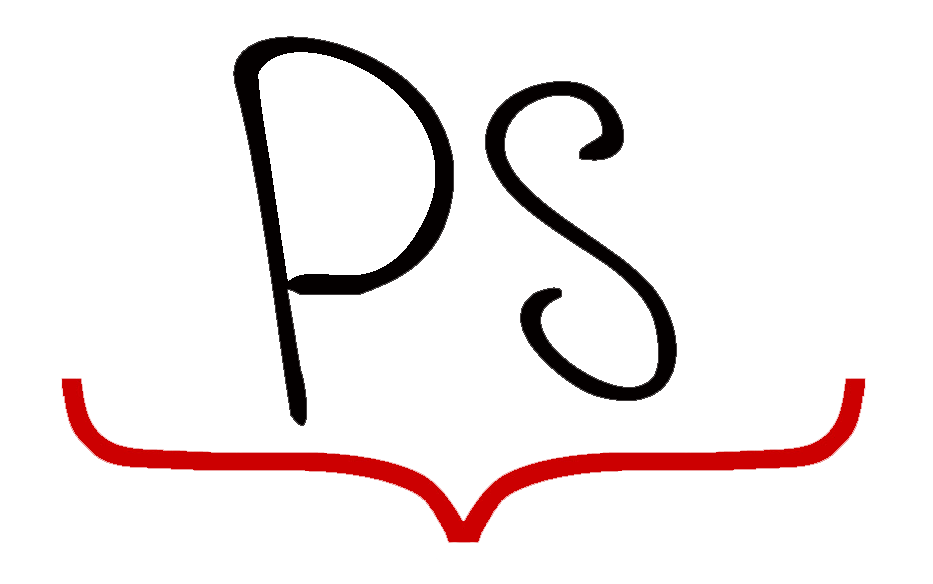Francesco Fontana, Verona –
“Costruzioni che potrebbero essere scuderie, granai, officine. Un terreno divenuto incolto, un cielo d’autunno indifferente. Ecco cosa resta per immaginare le notti interrotte da appelli […]. Una marcia d’operetta e si parte per la fabbrica […]. La zuppa. Un sorso in meno è un giorno in meno da vivere. Si barattavano notizie, vere o false. Si organizzavano gruppi di resistenza. Una società prendeva forma, scolpita nel terrore, ma meno folle dell’ordine delle SS coi loro precetti: La pulizia è salute; a ciascuno il suo”.
Sono alcune didascalie che accompagnano il film documentario di Alain Resnais Notte e Nebbia (1957). Pensieri disomogenei, tragici frammenti di non-vita nel campo. Scorrono le immagini dei reclusi nei lager, alternate a quelle girate, negli stessi scenari, dopo la fine della guerra: passata la notte rimane la nebbia di luoghi indifferenti, muti testimoni delle tenebre della storia.
Si può partire proprio da qui per introdurre il rapporto tra cinema e Shoah, prima di passare ad alcune delle numerose pellicole che hanno fatto ricorso al filtro della ricostruzione cinematografica per raccontare l’inenarrabile.
Il film francese è un tragico e crudo capolavoro. Resnais non ci risparmia nulla, a partire dagli sguardi delle vittime, vive o morte che siano. Occhi tutti uguali, quelli di chi ha superato il limite della sofferenza, e ci si può davvero chiedere Se questo è un uomo.
Nessuno si salva. Qualcuno sopravvive ma, varcata la soglia dell’orrore, la psiche rimane irrimediabilmente disturbata e l’individualità, sottratta per il periodo di reclusione, è, almeno in parte, perduta per sempre.
Ne dà una testimonianza anche la regista Liliana Cavani con il suo Il portiere di notte (1974), pellicola ambientata ben lontano dai lager, che riflette sulla relazione tra ex vittima e carnefice. Una donna di nome Lucia, sopravvissuta al campo di prigionia, rincontra circa dieci anni dopo Max, l’uomo che la violentava nel campo di concentramento quando era ancora bambina.
Ora Max è un portiere d’albergo e Lucia non è più la sua vittima, ma lo sono l’uno dell’altra. Nel contesto plumbeo della Vienna degli anni Cinquanta i loro sguardi si incontrano e il torbido vincolo sessuale riprende in una sorta di dipendenza reciproca.
L’inconscio più profondo dei protagonisti emerge in un film che, al momento dell’uscita, ha dovuto anche fare i conti con la censura per l’eccessivo erotismo. Altro aspetto inusuale: il protagonista, un nazista decontestualizzato dall’ambiente del lager, non viene presentato come mostro.
Max è un disturbato, un riflesso perverso di quella banalità del male riscontrata da Hannah Arendt nei burocrati “esecutori” nazisti. Il film è immerso in una nebbia fitta, dove la luce e il buio, il bene e il male si abbracciano nella riattualizzazione di un passato che prende le forme di un erotismo malato.
È l’arte ad essere violata ne Il Pianista (2002), film di Roman Polanski vincitore della Palma d’oro a Cannes. Iniziano i bombardamenti a Varsavia e una granata colpisce la sede della radio dove lavora il pianista Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), facendo crollare la stanza adiacente allo studio di registrazione.
Fuor di retorica, l’esplosione è l’emblema della prepotenza della guerra che schiaccia la bellezza delle note di Chopin che sta suonando il protagonista. Wladyslaw vende il pianoforte per necessità economica e viene trasferito nel ghetto di Varsavia.
Anche qui il percorso psicologico è al centro: si inscena la sofferenza intima dell’uomo, in una lotta per la sopravvivenza che si muove tra collaborazionismo e sforzi personali, con la musica quale vera linfa vitale e motivazione per non abbandonarsi. È la mente quindi, prima del corpo, a dover essere salvata, e tra le vie di fuga per evitare di inabissarsi c’è anche quella della bugia, della finzione.
La vita è bella di Roberto Benigni è forse la testimonianza più alta: mascherare al figlio l’orrore con il gioco è la strategia vincente, con gli aspetti più crudi, soltanto suggeriti, che rimangono sullo sfondo, nascosti dalla nebbia.
Percorre la stessa strada anche un’altra pellicola, di certo meno celebrata: Jakob il Bugiardo (1999), del regista Peter Kassovitz. Nel film il protagonista, interpretato da Robin Williams, finge di possedere una radio dalla quale riceve le notizie confortanti dell’imminente arrivo delle truppe sovietiche. Comunica ai suoi compagni ciò che vorrebbe aver sentito e dona speranza, alimentando così la vita.
Trattando il tema del rapporto tra Shoah e cinema non si può non citare il capolavoro di Steven Spielberg: Schindler’s List. Il regista sceglie il bianco e nero per rappresentare, appunto, un mondo senza colore. La narrazione è basata sulla storia vera di Oskar Schindler, l’uomo che ha salvato oltre mille ebrei dalla morte nei campi di sterminio.
C’è una vera e propria redenzione al centro della pellicola: il protagonista è un uomo che è riuscito ad estraniarsi dal sistema della burocrazia nazista, a opporsi alla meccanica fabbrica di morte che portava a compiere omicidi senza dare il reale peso al gesto.
Schindler ritrova invece la propria umanità, il valore della vita. Se il bianco e nero è il fil rouge c’è però un dettaglio: una bambina indossa un cappotto rosso, la vediamo passeggiare a inizio pellicola, poi la ritroviamo su un mucchio di cadaveri. Non è una morte qualsiasi, è la sua, che costringe a fare i conti con l’individualità, proprio quella annullata nei lager.
Forse è proprio questo il punto di forza della settima arte: la capacità di toccare le corde dell’emotività e di rendere immediatamente fruibile qualsiasi contenuto. Ogni film sulla Shoah, indipendentemente dal suo valore cinematografico, contribuisce alla conoscenza e alla memoria: è finzione che abbraccia la realtà.