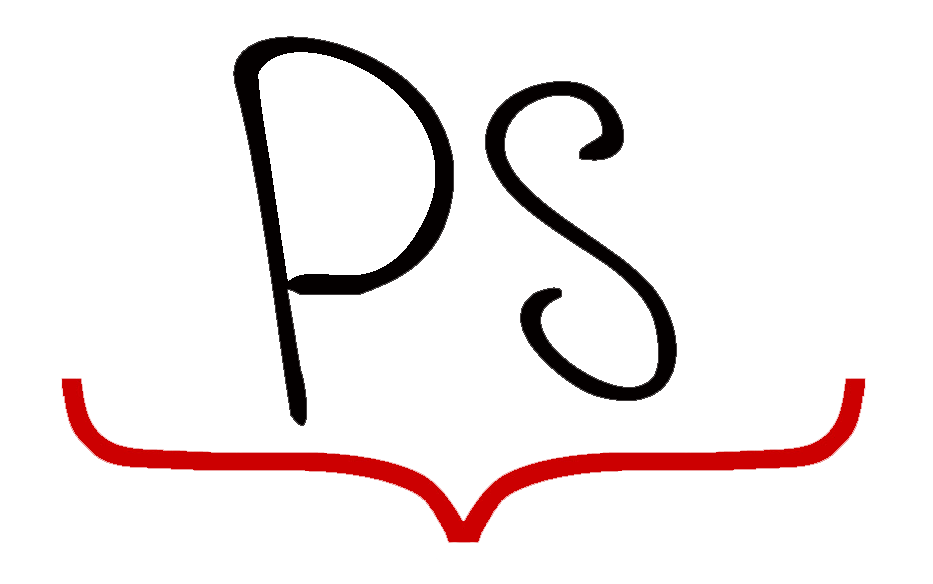Alessandro Rigo, Verona –
Innella città di Lucca, innella contrada di San Cristofano, fu uno pilicciaio, omo materiale e grosso di pasta in tutti i suoi fatti — nomato Ganfo —, salvo che alla sua bottega assai guardingo e sottile. Divenne che ’ ditto Ganfo infermò d’alcuna malatia e fu da’ medici lodato il bagno a Corsena esserli utile piutosto che le medicine; di che disposto il ditto Ganfo d’andare al bagno, chiese alla moglie, nomata monna Tedora, denari per portare al bagno e vivere. […] Giunto al bagno e andando a vedere lui le persone si bagnavano, vedendovi dentro centonaia di omini nudi, disse fra se medesmo: «Or come mi cognoscerò tra costoro? Per certo io mi smarirei con costoro se io non mi segno di qualche segno». E pensò mettersi in sulla spalla ritta una croce di paglia, dicendo: «Mentre che io arò tal croce in sulla spalla io sarò desso».
In questa novella di Giovanni Sercambi, il pellicciaio lucchese Ganfo, giunto al bagno pubblico per curare una malattia, spogliandosi e vedendo tutti quegli uomini nudi, in un attacco di panico per il timore di perdere la propria identità, decide di usare una croce di paglia per potersi riconoscere.
In sostanza, prima di essere veicolo di comunicazione del ruolo di un individuo nella gerarchia sociale, l’abito è innanzitutto l’elemento per eccellenza con cui egli riconosce la propria identità. Il fatto di abbigliamento analizzato da Roland Barthes, risulta in questo modo inserito in un determinato ambiente sociale – e ne subisce influenze di carattere culturale e psicologico – nella misura in cui esso rappresenta nella mentalità dell’individuo il modus induendi, il modello, l’immagine assunta in tale società dal proprio gruppo di riferimento. È appunto in questo senso che l’uomo medievale lega la manifestazione della propria persona ad un insieme di segni convenzionali, segni che, presi nel loro complesso, costituiscono la maniera con cui «ogni individuo partecipa all’armonia del corpo sociale, […] teoria di un ordine intangibile sottoposto allo sguardo divino» (Levi Pisetzky, 1964).
«L’abito nostro, senza dimostrarci/
Vi può far fede appunto chi noi siamo»
Canto dei Mugnai (XV-XVI secolo)
La manifestazione della propria condizione sociale attraverso una determinata tipologia di abbigliamento è in sostanza il mezzo con cui un uomo afferma nel vivere di ogni giorno la sua identità e allo stesso tempo viene identificato nella sua persona.

L’indossare abiti che non rispecchiano la propria condizione rende irriconoscibile l’individuo: si pensi al Tedaldo della novella boccaccesca che, tornatosene a Firenze in veste di pellegrino e creduto per morto, non viene riconosciuto dai parenti se non nel momento in cui «gittatosi la schiavina […] in una giubba di zendado verde rimase».
La riflessione che stiamo portando avanti ci impone naturalmente una preliminare attenzione alla distinzione tra una finalità sociale e una necessità puramente pratica dell’abbigliamento.
Il vestito inteso come elemento di protezione dagli agenti atmosferici o come strumento di lavoro rimanda principalmente a una questione di economia e funzionalità dell’abbigliamento che non esclude però automaticamente una valenza di rappresentatività. L’abito povero, prodotto grossolanamente e con tessuti di bassa qualità, può demarcare – ma non costituisce un’esclusività – esso stesso l’immagine di una determinata classe sociale, ovvero quella che può essere definita nell’ampia categoria medievale dei laboratores – in particolar modo, contadini delle campagne e salariati delle città – e implicare quindi allo stesso tempo una questione di identità all’interno di questi gruppi sociali: in poche parole, agli occhi della società medievale nel suo complesso, è elemento rappresentativo della categoria.

La camicia utilizzata dai contadini per lavorare nei campi. Il particolare è estrapolato dal ciclo di affreschi conservato presso la Torre dell’Aquila del Castello di Trento
Data la penuria di documenti che attestino testimonianze dirette delle fasce più povere della popolazione medievale, ricreare un quadro dettagliato del loro rapporto con il vestiario risulta pressoché impossibile. I pochi inventari di beni pervenutici per le fasce popolari ci mostrano, in ogni caso, che anche in questo ambiente sociale era sentita una distinzione tra abito da lavoro, di tutti i giorni, e abito ‘da festa’ – il quale era spesso prerogativa della donna e si tramandava nell’arco di molte generazioni. Un dato, questo, che ci permette di constatare che anche in tali ambienti sociali era sentita, con le sue implicazioni a livello di costume e atteggiamenti, una relativa separazione tra spazio privato e spazio pubblico, la quale si rivela maggiormente visibile man mano che si salgono i gradini della scala sociale.
Per le classi più abbienti si può infatti riscontrare una più netta separazione tra ‘abito da casa’, abito ‘mondano’ e quello cerimoniale. Logicamente, si tratta questo di un fatto che coinvolge questioni primariamente economiche: la differenziazione negli usi dei capi d’abbigliamento è direttamente proporzionale alle facoltà patrimoniali dell’individuo, attraverso le quali egli può avere accesso ad un numero di vestiti maggiore e di maggior pregio. In questo confronto, caso emblematico è quello della camicia che mentre presso gli strati popolari rappresentava l’abito per eccellenza, talvolta l’unico indossato da uomini e donne, o più spesso accompagnata da un grembiule o un guarnello e, in certi casi, anche da un mantello, nei ceti più abbienti e, in particolar modo, quelli cittadini, era considerata piuttosto un indumento di biancheria intima.
Nella novella boccaccesca dell’Angiolieri e del Fortearrigo, la camicia è sinonimo di povertà e in un certo modo anche di nudità: essere «in camiscia» valeva a dire non avere un soldo, essere stato colto da una «disavventura» il momento in cui il Fortearrigo, per inseguire l’Angiolieri, «così in camiscia cominciò a trottar dietro», lascia intendere che la cosa è tutt’altro che usuale, quasi scandalosa; infine, sempre il primo, derubando l’Angiolieri, si prende il suo cavallo e lo lascia «in camiscia e scalzo», come un poveraccio.

Si è detto quindi della camicia come topos che definisce una situazione di povertà e, per estensione, di nudità: questo indumento era quindi per antonomasia, tra gli strati più elevati, l’abbigliamento da casa, al modo di una vestaglia, indossato quindi in uno spazio privato. Ciò non significa necessariamente che fosse di poco pregio. Sicuramente non era tra i capi più lussuosi del corredo familiare, ma poteva certamente essere realizzata con tessuti di ottima qualità. La camicia da uomo, come capo di biancheria, poteva essere invece portata in ogni momento della giornata, a modo di una moderna canotta, tant’è che in un disegno del Pollaiolo della metà del Quattrocento si può vederla spuntare da sotto il farsetto – attillatissimo – in una posizione che era però considerata sconveniente, di cattivo gusto. In ogni caso, fino agli ultimi decenni del Trecento, la biancheria non fu molto usata, o almeno, in misura sicuramente minore rispetto al secolo successivo.
Per quanto i pochi dati a nostra disposizione ci permettano di comprendere l’estrema essenzialità dell’abbigliamento contadino, bisogna sempre tenere conto, però, che la gran parte delle fonti è spesso proveniente da altri contesti sociali. Questo vale per le fonti legislative, così come per quelle letterarie o iconografiche.
Proprio queste ultime necessitano di un’attenzione particolare in quanto, essendo principalmente espressioni della classe sociale dominante, in esse la raffigurazione dell’abito è spesso caricata di un valore simbolico, ideologico e didascalico.
Prendiamo, ad esempio, la questione della affermazione di un ceto ai vertici dell’ordine sociale: essa appare strettamente legata alla definizione – almeno sul piano teorico – di una serie di atteggiamenti sostanzialmente moraleggianti e virtuosistici che, fungendo da modelli, erano alla base del prestigio non solo della classe sociale stessa, ma anche del singolo individuo ad essa appartenente.

Il linguaggio scelto per rappresentare e diffondere questi modelli identitari non poteva che essere l’arte figurativa, che in questo senso si caricava di un messaggio strettamente politico-sociale, il quale poteva realizzarsi sostanzialmente in due vie: da una parte nella rappresentazione regale dell’immagine divina, della Vergine come del Cristo o della moltitudine dei santi; dall’altra attraverso il motivo ritrattistico, a fini votivi, che prese voga principalmente dalla seconda metà del Trecento.
Le vesti, all’interno di questo sistema rappresentativo, giocavano quindi una funzione ambivalente, a metà tra la manifestazione delle virtù aristocratiche e la necessità di contestualizzare questi intenti di affermazione sociale in uno spazio temporale concreto, reale, ben definito.
É in quest’ultimo ambito che la raffigurazione iconografica può esercitare un ruolo di influenza sull’idea, sul modello di abbigliamento cui una determinata classe sociale – e la società nel suo complesso – tendeva a concretizzare, e può rientrare, in un certo modo, in una concezione didattica dell’arte figurativa di cui già Gregorio Magno era pienamente cosciente alla fine del VI secolo:
«La pittura adempie per gli illetterati la stessa funzione che ha la scrittura per chi sa leggere; nella pittura gli illetterati vedono gli esempi da seguire, in essa leggono coloro che non sanno leggere; e le immagini sono state poste nelle chiese non per essere adorate, ma solo ed esclusivamente per istruire la mente degli indotti».
LE LETTURE CONSIGLIATE:
- G. Sercambi, Novelle, a cura di G. Sinicropi, I, Bari, Laterza, 1972
- R. Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, II, Milano, IEI, 1964
- P. Braunstein, Approcci all’intimità. Secoli XIV-XV, in La vita privata. Dal Feudalesimo al Rinascimento, a cura di P. Ariès-G. Duby, Roma-Bari, Laterza, 1988
- M.G. Muzzarelli, Vestire a festa, in Festa e politica e politica della festa nel Medioevo. Atti del convegno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 1-2 dicembre 2006), a cura di A. Rigon, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2008
- G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Milano, Mondadori 1985
- C. Merkel, Come vestivano gli uomini del Decameron, Roma, Tip. R. Accademia dei Lincei, 1898
- Disciplinare il lusso: La legislazione suntuaria in Europa tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di M.G. Muzzarelli-A. Campanini, Roma, Carocci, 2003
- G. Muzzarelli, Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo, Bologna, Il Mulino, 1999