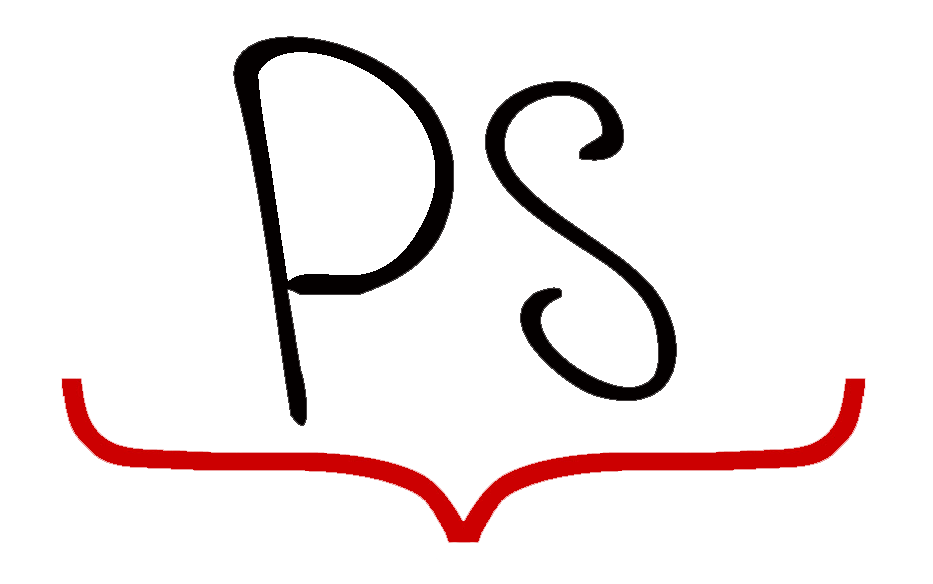Giuseppe Catterin, Venezia –
La capacità di maneggiare il fuoco, la conoscenza della sua utilità nonché dei rischi e pericoli ad esso legati (quanto meno, si spera), sono fattori e competenze universali, riscontrabili in tutte le società umane conosciute, indipendentemente dal grado e dalle capacità tecnologiche in possesso: forme di vocalità, ascrivibili alla sfera – seppur rudimentale – del linguaggio sono presenti in buona parte del mondo animale; e sempre dal mondo animale, in particolar modo tra i primati, ci provengono esempi di utilizzo proficuo di strumenti basilari, atti, ad esempio, a migliorare la caccia o la raccolta di materie prime necessarie al sostentamento del singolo o della comunità.
Ma, limitatamente al fuoco, solamente il genere umano ha imparato, come parte di un bagaglio culturale indelebilmente impresso nelle più intime fibre della specie, ad utilizzarlo: fin da piccoli siamo soliti ammirarlo; crescendo, invece, ci è stato insegnato a controllarlo nella maniera più sicuro, fino ad arrivare ad apprendere come maneggiarlo al meglio e, soprattutto, come “evocarlo” quando ritenuto necessario. Anzi, senza rischiare di esagerare, si potrebbe, come breve chiosa di questo ragionamento, aggiungere che la nascita dell’Uomo si possa far partire dall’inizio della storia dell’ “addomesticamento del fuoco”
Le sue caratteristiche, la familiarità che abbiamo con esso, la sua presenza, a tratti, quasi scontata, si sono, oltretutto, profondamente stratificate nel linguaggio quotidiano, andando a creare metafore e frasi idiomatiche di facile ed immediata comprensione presenti nella lingua italiana e non solo. Senza scomodare studi ben più specifici, espressioni quali “mettere a fuoco”, “dare fuoco alle polveri”, “fuoco di paglia”, sono, il più delle volte, di uso relativamente comune; la loro efficacia espressiva, d’altra parte, si basa su di alcune caratteristiche (come, ad esempio, il “far luce”), tipiche del fuoco o sulla sua differente reazione al variare del combustibile: anche se completamente scevri delle più basilari nozioni di agraria tutti sappiamo la scarsa durata di un focolare alimentato da un combustibile dal basso tenore calorico come la paglia.

Una scena di lotta; incisione rupestre conservata a Capo di Ponte, in Val Camonica
Tuttavia, limitare il fuoco a rango di semplice elemento naturale che, come si è poc’anzi visto, assume un certo rilievo nella panoramica culturale, indicarlo come mero processo di trasformazione della materia in altre forme e “prodotti” strettamente necessari alla sopravvivenza umana – energia, luce e calore in primis –, può risultare oltre modo insoddisfacente ai fini della comprensione, seppur limitata visto il differente punto di vista su cui si vorrà soffermare il seguente lavoro, dell’importanza attribuita, fin dai tempi più remoti, a tale fondamentale risorsa del genere umano.
Precedentemente si è intenzionalmente utilizzato il termine “evocare”; si alludeva, infatti, alla lunga tradizione “divina” legata al fuoco, paradigma della consapevolezza umana dell’importanza di tale “conquista”. Secondo la mitologia greca, la conquista del fuoco avvenne mediante l’azione diretta di una entità superiore, dalla natura semidivina: il titano Prometeo, presentato, nella tradizione mitologica, come l’antitesi di Zeus, decise di sottrarre il fuoco alle divinità per poterlo così donare all’Essere Umano.

Il mito di Prometeo
Presso i Romani, la divinizzazione del fuoco, elevato al rango di nume protettore della dimora nonché espressione “vivente” della dea Vesta, si può efficacemente riscontrare se si tiene in considerazione il prestigio riservato dalla società romana al sacerdozio delle Vestali: stando alla leggenda, Romolo e Remo erano figli di Rea Silvia, vestale originaria di Albalonga; le ragazze scelte per tale ufficio godevano, presso l’antica Roma, di uno status certamente invidiabile (tant’è che nei primi secoli della Roma arcaica il sacerdozio era riservato unicamente alle ragazze provenienti dalle famiglie di rango patrizio).

Un bassorilievo raffigurante le Vestali
D’altro canto, il loro compito era di vitale importanza all’interno del sistema di credenze romano: lo spegnimento, anche solo accidentale, del pubblico e sempiterno focolare, la cui cura quotidiana spettava proprio al collegio delle vestali, poteva destare grandissima preoccupazione fra i Romani. Ma è nella tradizione veterotestamentaria che la sacralità del fuoco assume una vastissima gamma di modulazioni, divenendo l’unico elemento naturale degno per rappresentare al meglio la teofania.
In merito, per facilità di comprensioni, basti pensare all’episodio del “roveto ardente”. In tale frangente, a Mosè, chiamato da Jahvè ad essere guida del popolo d’Israele, apparve l’angelo del Signore attraverso l’emblematica forma di fiamma che ardeva senza, però, consumarsi. Arrivati a questo punto ci si può lecitamente domandare quali siano, ai fini della discussione che anima l’articolo, le motivazioni che hanno spinto, in questo breve excursus, a citare la Bibbia. La citazione del passo biblico, tralasciando le implicazioni di carattere religioso, ci fornisce il giusto esempio di una declinazione dell’uso del fuoco sovente passata inosservata.

La raffigurazione del Roveto ardente nella Cappella di Mosè, Basilica di San Marco, Venezia (photo/Scala)
L’espressività dell’immagine – e, quindi, la scelta di utilizzarla per rendere al meglio una tra le teofanie più importanti nel panorama veterotestamentario – del roveto che arde senza però consumarsi trae certamente giovamento dalla natura fortemente icastica presso i primi lettori (il popolo d’Israele), a cui il testo era rivolto: il rogo delle sterpaglie, in una fase della storia dell’agricoltura precedente l’utilizzo dei concimi chimici, costituiva una delle primissime fasi della preparazione dei suoli per la pratica agricola. Ardendo e consumando l’incolto, le fiamme praticavano una prima, ed importantissima, operazione di diserbo, soprattutto delle eventuali tracce di colture precedenti, conseguenza naturale della prassi della rotazione delle colture.
Ma, più di tutto, la cenere così prodotta andava ad implementare i suoli di nutrienti, fosfato in primis, strettamente necessari al ciclo di crescita della coltura messa a dimora. La fortuna di tale tecnica di coltivazione, caldamente raccomandata anche nella cultura classica (Virgilio, nelle sue Georgiche, consigliava l’utilizza della cenere per rinvigorire i suoli depauperati dall’eccessivo sfruttamento), ci viene suggerita anche da Sereni.
Lo storico, infatti, nel suo saggio Terre nuove e buoi rossi, riporta una interessante esperienza personale appresa durante un suo soggiorno in Calabria a metà degli anni ’70 del Novecento. Qui, parlando con un boscaiolo locale, venne a conoscenza della storia di un contadino e del mago Salomone. Quest’ultimo, interrogato dal primo, oberato dalla miseria dovuta a scarsi raccolti, suggerì d’utilizzare “terre nuove e buoi rossi”. Il vaticinio, come ci si può ben immaginare, appare brillare per una non facile e immediata comprensione e, soprattutto, interpretabile in numerosi e differenti modi; e così effettivamente, stando al racconto, fu: il contadino, ragionando in maniera pragmatica, decise, peggiorando ulteriormente lo stato delle proprie ricchezze, di andare a comperare una coppia di buoi dal manto rosso. Ma, nonostante l’acquisto, le terre risultavano essere ancora infruttuose. Udite le rimostranze del contadino, il mago Salomone rispose, decifrando il suo consiglio: le terre del contadino erano state messe così tanto a coltura da depauperarsi di qualsiasi materia prima necessaria alla corretta crescita delle colture. Serviva, dunque, “terra nuova”, vale a dire un pezzo di foresta che “mai ad alcuno diede ancora raccolta di segale o di grano”; terra che poteva venir messa a coltura unicamente mediante l’utilizzo dei “buoi rossi”, vale a dire le fiamme opportunamente controllate mediante, il più delle volte, la creazione di “dighe” capaci di evitare una loro propagazione incontrollata.
La preparazione del terreno tramite l’utilizzo dell’incendio, sia esso totale (ogni qualvolta, come nel caso presentato da Sereni, si volesse strappare alla foresta nuovi terreni da coltivare) o anche solo parziale – vale a dire limitarsi a bruciare le sterpaglie di un lotto già messo a coltura – non deve, però, assolutamente venir intesa come “opera predatoria”: la silvicoltura, nonostante la crescente fame di spazi coltivabili dovuti ad un esponenziale aumento della pressione demografica, si manteneva una pratica agricola troppo importante da poter permette una sua veloce e completa perdita. Oltre a fornire materie prime di vitale importanza per il soddisfacimento di una vastissima quantità di esigenze – in primis, combustibile a basso costo –, la coltura della foresta rappresentava – e continuò lungamente a farlo – la soluzione migliore per l’allevamento suino: fino all’introduzione della coltura della patata, i maiali vennero a lungo nutriti soprattutto grazie all’apporto di alimenti tipici della foresta, ghiande in primis (non a caso, nell’agrimensura medievale, il bosco, sovente, veniva “misurato” basandosi sulla quantità di maiali che poteva sfamare).
E per quanto concerne la vastità di materie prime di valore che i boschi continuarono a fornire, la Serenissima, a seguito dell’espansione in Terraferma, si garantì il monopolio, il controllo e la cura di vaste distese boschive – selve del Cansiglio e del Montello, in primis – capaci di soddisfare al meglio le esigenze dell’industria della cantieristica, fiore all’occhiello dell’apparato produttivo lagunare nonché puntello su cui si poggiava la politica di potenza di Venezia. I disboscamenti, dunque, procedevano sempre in maniera “selettiva” – si sceglieva di salvaguardare una specie arboricola piuttosto che un’altra – andando così a creare un paesaggio agricolo ove foresta e coltivo s’alternavano frequentemente. Ma, soprattutto, selezionando, di volta in volta, i terreni da mettere sotto coltura, e lasciando quindi larghissimo spazio all’incolto, si dava alla foresta il tempo di rigenerarsi naturalmente.
La spiegazione della fortuna di tale pratica agricola, efficace pur nella sua semplicità, va forse ricercata nella mancata cooperazione tra agricoltura e allevamento – se non addirittura nella forte tensione tra questi due settori agricoli. Le forme medievali di quest’ultimo, infatti, erano ancora incentrate pesantemente sulla natura transumante, delle greggi; ciò comportava, a differenza dell’allevamento a stalla, una minore produzione di liquami da poter investire nella rivitalizzazione di suoli depauperati dallo sfruttamento agricolo. Conseguentemente, la cenere rimaneva – e rimase a lungo – l’unico fertilizzante a buon mercato.
LE LETTURE CONSIGLIATE:
- B. Andreolli, L’uso del fuoco nelle pratiche agricole, in “Atti delle settimane”, LX (2012), pp. 735-753. Spoleto, Centro Italiano di studi sull’alto Medioevo, 2013.
- G. Forni, Fuoco e agricoltura dalla preistoria ad oggi. Storia e antropologia di un plurimillenario strumento di lavoro, in “Rivista di Storia dell’Agricoltura”, a. LI, N.2, (dicembre 2011)
- J. G. Frazer, Miti sull’origine del fuoco, Xenia, Milano, 1993
- J. Goudsblom, Fuoco e civiltà: dalla preistoria ad oggi, Donzelli, Roma, 1996
- M. C. Martini, Le vestali: un sacerdozio funzionale al “cosmo” romano, Latomus, Bruxelles, 2004
- C. Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, Mondadori, Milano, 1992
- E. Sereni, Terra nuova e buoi rossi e altri saggi per una storia dell’agricoltura europea, Einaudi, Torino, 1981