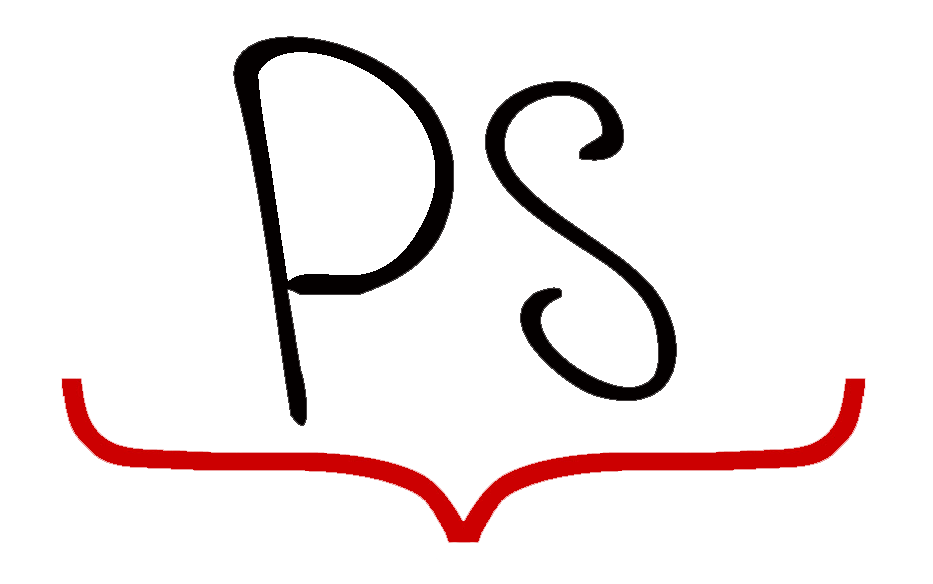Marco Alpan, Torino –
Satura quidem tota nostra est
“La satira è tutta farina del nostro sacco”, scriveva con orgoglio e con un pizzico di vanità Quintiliano nel suo decimo libro dell’Institutio oratoria. E aveva di certo un buon motivo per rimarcarne la paternità tutta latina: la satira era considerata, infatti, l’unico genere letterario che i Romani non avessero ripreso dai loro cugini Greci, primi in ogni ambito della letteratura, tranne che in questo. L’origine del nome è indicativo delle caratteristiche più significative del genere. La satura lanx in principio era un piatto di offerte votive per gli dei, composto da molteplici varietà di primizie. Proprio da questo dettaglio si può capire bene il perché della promiscuità della satira, che riuniva in sé i tratti salienti tipici di diversi registri stilistici.
Ogni genere letterario che si rispetti ha il suo campione in carica e quello della satira è Giovenale. È vero che non ne fu l’iniziatore – viene tradizionalmente riconosciuto come tale Lucilio, anche se probabilmente Ennio lo anticipò. Inoltre, non fu l’unico a praticarla – si pensi a Orazio o al quasi contemporaneo Persio – e forse il suo nome è meno conosciuto di Marziale, il quale si rifà alla satira per certi aspetti. E allora perché insignirlo degli allori?

Affreschi pompeiani
Innanzitutto è bene sottolineare che gli storici della letteratura individuano due generazioni di autori di satire; alla prima appartengono Ennio, Lucilio e Orazio, alla seconda i restanti. La prima generazione sviluppa una concezione del genere ancora distante da quella che impregnerà i versi di Giovenale: si pensi, ad esempio, alla celebre satira del seccatore di Orazio. Qui i toni sono tipici di un colloquio a tu per tu con il lettore e la forma del discorso si basa sulla complicità con quest’ultimo. Nella seconda generazione, invece, stando alle preziose parole di Gian Biagio Conte, “l’invettiva – la denuncia impietosa che abbassa e distrugge – prende il posto del modo confidenziale e garbato, del sorriso autoironico, dell’indulgente comprensione per le comuni debolezze umane che caratterizzavano la satira oraziana”.
E proprio l’invettiva è lo stilema che meglio si confà alla nostra idea del genere e che non a caso, come abbiamo appena detto, contraddistingue la seconda generazione di autori, dove, però, non troviamo una sostanziale uniformità di fondo. Troviamo, infatti, da una parte un Persio isolato nella sua torre d’avorio dello stoicismo e dall’altra un Marziale versato negli epigrammi, che, solo nella loro veste scoptica si possono richiamare alla satira.
Finalmente, eliminati tutti i contendenti in lizza, possiamo ufficialmente proclamare Giovenale il nostro campione indiscusso della satira, nonché suo ultimo degno rappresentante.

Affreschi pompeiani
Frammentarie e in alcuni casi scarsamente attendibili le notizie sulla sua vita. Nato ad Aquino, nel sud del Lazio in un anno non ben precisato tra il 50 e il 60 d. C., esercitò dapprima la professione di avvocato, ma con risultati deludenti. All’attività poetica arrivò solo in età matura, probabilmente dopo la morte di Domiziano, nel 96, anche se nemmeno questa poté garantirgli un’indipendenza economica a tutti gli effetti, dal momento che Giovenale visse nella condizione di cliente fino alla sua morte, sopraggiunta dopo il 127. Di lui ci restano le sue Satirae: sedici componimenti suddivisi in cinque libri.
Parecchio di più, invece, si può dire sulla sua visione della vita, improntata sull’indignatio, su un pessimismo di fondo dilagante, non scevro, però, di ironia e di autocommiserazione.
Ma dove vanno ricercate le radici di una visione esistenzialistica così cupa? Nella stessa biografia dello scrittore, il quale, come detto, per sbarcare il lunario era costretto a piegarsi in maniera servile alla volontà di un patronus; tale comportamento agli occhi di Giovenale stesso costituiva un fatto aberrante per un letterato, portavoce per eccellenza della più sublime delle arti. È proprio da qui che prende piede l’indignatio di Giovenale, convinto che la società romana a lui contemporanea versi in un totale degrado e che la sua acme si sarebbe raggiunta nel relegare con apatica indifferenza gli intellettuali ai margini del cuore pulsante di Roma. È, dunque, lo stesso sdegno a comporre:
Ma se la natura rifiuta, è l’indignazione a far versi, come sono capace di farli io o Cluvieno.
E non finisce qui. Il nostro scrittore di satire si spinge anche oltre, tanto da affermare che, contrariamente a quanto ci aspetteremmo, la sua poesia non può cambiare la situazione attuale in quanto corruzione e immoralità sono insite nell’animo umano e perciò non estirpabili.
La critica alla società si accompagna di pari passo alla polemica letteraria che infiamma fin dalla prima satira, dove Giovenale sbotta dicendo: “Semper ego auditor tantum?” – “Dovrò sempre e solo stare ad ascoltare? – lanciando una frecciatina piena di veleno ai tanti poetastri attivi nella Roma della fine del I secolo. In un momento dove ognuno poteva improvvisarsi prescelto dalle Muse ispiratrici, gli scribacchini si confondevano con i sommi poeti. Giovenale, quindi, stanco di sentirsi tormentare a ogni angolo della strada dalla mediocre “Teseide di quel Cordo ottuso” o da “un Oreste […] che non finisce mai”, decide di mettersi in gioco in prima persona. D’altronde, “è stupida clemenza, in questo brulicare di poeti, graziare carte destinate al macero”.

Il frontespizio di una traduzione inglese di Giovenale e Persio, curata da John Dryden nel 1711
L’obiettivo principale di Giovenale, però, è quello di mettere alla berlina i peccati e i peccatori della Roma del suo tempo, a iniziare dai cacciatori di testamento, passando per i finti astrologi pronti a truffare i malcapitati creduloni, per gli adulatori, fino poi ad arrivare agli arrampicatori sociali. Nessuno viene risparmiato. Nemmeno i senatori, che sono il bersaglio prediletto del suo quarto componimento, noto come Satira del rombo, in cui il poeta immagina una seduta dei patres conscripti convocati in fretta e furia per discutere di una faccenda di capitale importanza.
In pratica, un pescatore offre in dono a Domiziano un rombo di dimensioni ciclopiche e nessuna pentola era adatta a contenerlo. L’imperatore allora manda a chiamare i senatori per discutere su quale potesse essere il modo migliore di cucinare il pesce. La tragicomica situazione è in realtà un pretesto bell’e buono per Giovenale per esporre al ridicolo i nomi di alcuni patrizi dell’epoca, macchiatisi delle colpe più disparate. Ne cito uno stralcio, a partire dal verso 65:
Si va dall’Atride [Domiziano] e l’uomo del Piceno [il pescatore] dice: ‘Accettalo;/è troppo grande per una casa privata. Sia questo/un giorno di festa; affrettati a sgombrare lo stomaco/e consuma il rombo destinato al tuo regno./È stato lui che ha voluto farsi prendere”. Che c’è di più sfacciato? /Eppure l’imperatore alza la cresta; non c’è niente/che non sia capace di credere sul proprio conto quando si innalza alle stelle/il suo giusto potere! Ma mancava una padella della misura del pesce./Si chiamano dunque in consiglio tutti i potenti, quelli che odia […].
L’opera più famosa di Giovenale, però, resta la celeberrima Satira VI, che gli valse l’accusa di misoginia. Si tratta del suo componimento più lungo, dove, in quasi settecento esametri, critica il mondo delle matrone romane, responsabili anch’esse del degrado morale di Roma. A dire il vero, grazie ad un’analisi attenta ed accurata, si può evincere come Giovenale non si scagli contro tutte quante le donne, ma solo contro una parte di loro, cioè con quelle divenute con il passare del tempo oziose e dissolute, pigre, volgari e senza senso del pudore: le matrone.
Di conseguenza, parlare di misoginia indiscriminata pare soverchio e scorretto, sebbene non vada dimenticato che il poeta fa uso nella satira di toni tutt’altro che attenuati, come dimostra in maniera perspicua l’incipit:
Certamente un tempo eri sano di mente e ora, invece, prendi moglie Postumo? […]/Puoi sopportare una donna pur avendo così tante corde a disposizione,/mentre sono spalancate delle finestre alte e che danno le vertigini/e ti si offre il ponte Emilio vicino?
Tradotto in parole povere: meglio suicidarsi che legarsi in matrimonio con una donna.
LE LETTURE CONSIGLIATE:
- G. B. Conte, Lezioni di letteratura latina 3, Milano, Le Monnier, 2010
- G. Giovenale, Satire, Roma, Feltrinelli, 2013