
Nelle nostre mappe mentali abbiamo doppiato la spazialità allungata, stiracchiata che ci siamo abituati a vivere quotidianamente, ma vi abbiamo impresso e tracciato anche i muri, le recinzioni, i fossati su cui ogni giorno ci imbattiamo quando vogliamo spostarci con l’unico mezzo veramente e più propriamente nostro: i nostri piedi.
Francesco Bastianon, Venezia –
Se è vero che il tempo travolgerà tutte le parole e tutte le cose, è vero anche che alcune saranno investite dalla sua demolizione prima di altre: alcune parole prima di altre parole, alcune cose prima di altre cose. Ma, anche, alcune parole prima di alcune cose e alcune cose prima di alcune parole.
È, soprattutto, il destino di quelle parole che non sopravvivono alle cose cui si riferiscono: come non ricordarsene ogni volta che si considera quante macerie di parole e cose antiche il tempo si è lasciato dietro, di quel mondo arcadico che era la campagna italiana prima del boom economico ed edilizio; un luogo del mondo e dell’animo, rigoglioso di particolari parole e di particolari cose, finché non fu travolto, non solo dal tempo, ma anche dalla colata del cemento del progresso e della società liquida.
Anche le abitudini, assieme a parole e cose, sono ugualmente soggette alla macina che ruota sospinta dallo scorrere del fiume del tempo in cui sono pienamente immerse le sue pale. Così, ormai, nessuno più, quando si sposta, prende scorciatoie attraverso i campi. No, suona brutta così! Meglio: nessuno più taja par campi. Stessa cosa, diverse parole e, quindi, forse, proprio un’altra cosa. Un’espressione veneta schietta e sintetica che aderisce perfettamente all’azione cui fa riferimento: tajàr par campi, percorrere il minor segmento nel muoversi da un punto A a un punto B. O, almeno, così è come mi hanno insegnato a pensarla quando ho intrapreso i primi studi elementari.
Mio nonno, che era un uomo analfabeta, senza una consapevolezza scolasticamente definita degli enti geometrici fondamentali, non faceva, istintivamente, altro che coprire la distanza tra dove era e dove voleva andare secondo il percorso più sensato: appunto, tajando par campi. Camminava in linea d’aria – ma non sarebbe meglio parlare di “linea di terra”? – perché il suo passo era libero come se si librasse in cielo e, come nella volta celeste, era abituato a non vedere ostacoli nemmeno sulla terra. Non conosceva strade perché non ne aveva bisogno.
Quando, invece, io tornavo a casa a piedi dalla fermata dell’autobus, terminata l’ennesima giornata di scuola, ci mettevo almeno un quarto d’ora per arrivare a destinazione. Ce ne avrei messo, probabilmente, meno della metà, se non avessi seguito la sinuosa serpentina della strada asfaltata e mi fossi azzardato a inventarmi un sentiero, improvvisandolo tra le campagne. Ma ai piedi avevo le scarpe belle, le “scarpe da festa” – è che, ormai, è sempre festa – e non potevo sporcarle nel fango, sull’erba alta, tra le piante. Indossavo anche quel Super-io tipico della mia epoca che mi ingiungeva di non uscire di strada, di non addentrarmi per spazi non antropizzati dal bitume, di seguire il percorso, di muovermi solo nella direzione delle strane vie che prende la civiltà.
Camminavo di più, ma, perlomeno, avevo tempo per riflettere. Così, portavo a passeggio le mie considerazioni e le impilavo l’una sull’altra al ritmo dei piedi che si rincorrevano a vicenda. Pensavo al passo dell’uomo di oggi – il passeggio è, forse, l’unica vera affermazione di libertà assoluta nello spostamento -, che non si muove più in ogni direzione. Pensavo alla nostra nuova concezione di spazio: una spazialità che ha pagato il suo slancio oltre l’orizzonte, verso le mete più lontane, con lo sfilacciarsi e l’assottigliarsi della sua area. Pensavo che, prendendo un volo, possiamo essere in un paio d’ore a Londra, in una dozzina di ore al di là dell’Oceano, che possiamo visitare il Taj Mahal, prendere il sole alle Maldive, pranzare a Singapore, che un treno ad alta velocità ci porta in quattro ore a Roma; ma che ci è proibito mettere piede nel prato davanti casa, perché ce lo impedisce una recinzione o un fossato. Pensavo che siamo liberi di andare ovunque, purché lì ci conduca una striscia d’asfalto, un aereo, un treno. Pensavo che è proprio per questo che asfaltiamo il mondo: perché siamo liberi, ma non, poi, così tanto.
Così, offriamo lo spettacolo di esseri zigzaganti e imbottigliati nel traffico che girano e girano e girano a caccia di un parcheggio, eternamente in coda, perennemente nervosi, imprigionati nei filamenti del reticolo stradale che è divenuta ormai la mente umana, incapace di concepire un mondo ampio, spazioso, libero, non reticolare, non esile come la lisca di un pesce, non irto di ostacoli e barriere. Nelle nostre mappe mentali abbiamo doppiato la spazialità allungata, stiracchiata che ci siamo abituati a vivere quotidianamente, ma vi abbiamo impresso e tracciato anche i muri, le recinzioni, i fossati su cui ogni giorno ci imbattiamo quando vogliamo spostarci con l’unico mezzo veramente e più propriamente nostro: i nostri piedi. Anche nel pensiero abbiamo smarrito il tajàr par campi.
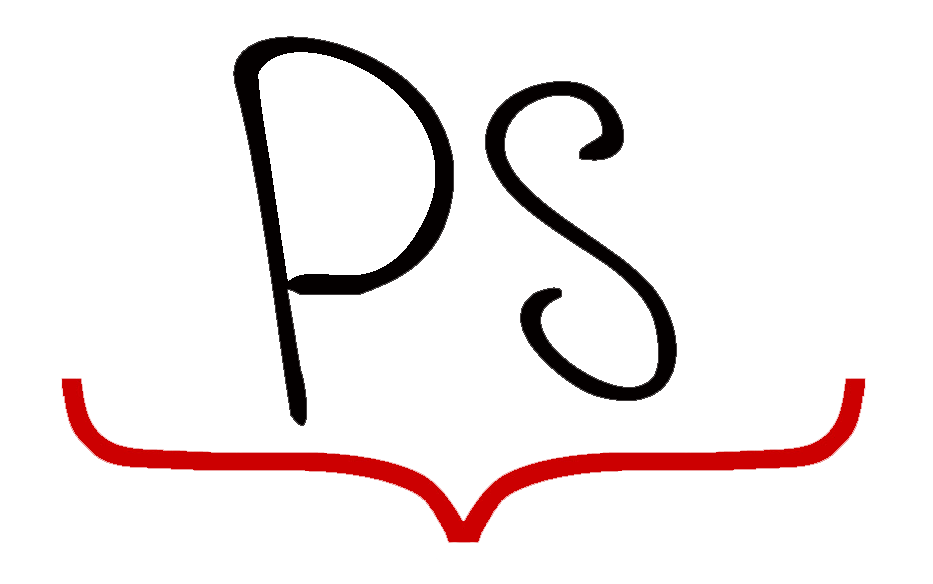
Pensiamo di essere liberi ed invece non lo siamo per nulla…. comunque sia alla base c’e la perdita di valori autentici come amicizia e rispetto degli altri: chi mi vieta di passeggiare col cane tra i campi: la paura di non esser vista dai cacciatori, un proprietario di galline spaventato dal mio Fido, il cartello proprietà privata… peccato non godersi con vera libertà la terra “bene comune” di tutti