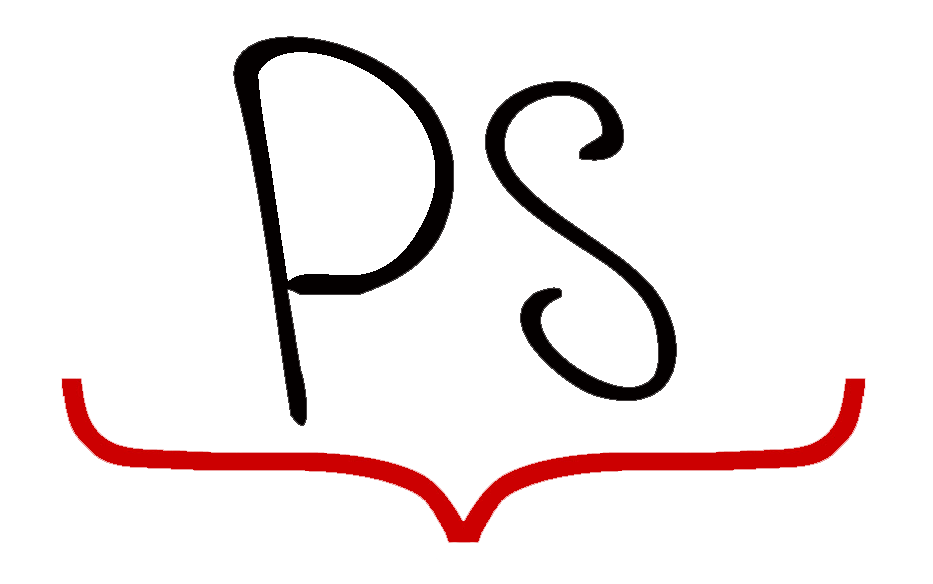Enrico Ruffino, Venezia –
Da quando, il 4 marzo, il fluido scorrere dell’incertezza ci ha condotti, con una impasse di ben 4 lunghi mesi, al bivio storico del governo “giallo-verde” – truce espressione cromo-giornalistica che vuole indicare l’alleanza di governo tra le forze generalmente definite “populiste”: la Lega (ex) Nord e il Movimento 5 stelle – la parola “fascismo” è ritornata prepotentemente nel discorso pubblico, assumendo – specie per la sinistra: una categoria politica tanto facile da pronunciare quanto difficile da spiegare – un valore terribilmente evocativo. È sembrato a molti, infatti, che si fosse dinanzi ad una svolta regressiva, caratterizzata dalla riapparizione di forze che si pensava sopite ma ora, in una dimensione tutt’altro che locale ma anzi globale, risvegliatesi con una potenza incontrastata, pronte ad insidiarsi e a serpeggiare tra le file della società scuotendo, con i loro mille tentacoli, le loro mille pulsioni irrazionali e “illiberali” da tempo relegate ai margini della storia. Forze che sembravano – e sembrano tutt’ora a qualcuno – la plastica rappresentazione di un qualcosa di tanto vecchio quanto doloroso e insidioso, una sorta di sintesi del male che ingloba tutto – dalla politica alla cultura, dall’antropologia alla biopolitica – in un immenso vaso di pandora sempre apribile: il “fascismo”. A ben vedere, però, la questione appare decisamente più complicata.
Un “mostro” senza volto
Parlando a titolo personale, a nove mesi di distanza, mi accorgo di vedere, in quella complicata situazione, il culmine elettorale di un processo su scala globale del tutto nuovo. Il problema è che non vedo il pericolo del vecchio mostro, ne vedo uno nuovo, inquietante, senza un volto. Perché egli sfugge all’analisi, scorrendo come un fluido ininterrotto e in insistente mutamento. Perché questa continua e imperterrita trasformazione mi impone di cambiare in maniera drastica le mie analisi. Ed è forse in questa sfuggevolezza che risiede il rischio: perché così vedo un potere, che si forma nella liquidità, impersonato dalla geopolitica della leadership mondiale e dalla sfacciataggine con il quale si presenta come vox populi, infimamente ostentato dalla possessione di un discorso, quello securitario, di impellente emergenza. Un discorso – una episteme direbbe Foucault – all’interno del quale si declinano altre narrazioni comprendenti le questioni più cogenti dell’attualità (il terrorismo, l’immigrazione, la violenza) ma che, allo stesso tempo, diventa ancora più pervasivo – efficace, per dirla con Hayden White – perché dominatore della comunicazione post-vera: un flusso incessante di informazioni e di piattaforme che donano la parola – citando Maurizio Ferraris – a “milioni di persone convinte di aver ragione non insieme ma da sole”. Se ne deduce: il potere è di chi riesce a comunicare con efficacia nel singolo individuo. È ciò che riescono sorprendentemente a fare i cosiddetti “populisti”, sfruttando quell’incapacità – quella nostra impotenza – a dare il nome alle cose.

Concettualizzare il nuovo: una paralisi dei nostri tempi
Ma è davvero un sentimento solo personale? A rifletterci, la mia inquietudine è un tratto forse più socio-antropologico che personale. Sarà frutto della diaspora intellettuale e politica che, a partire dalla fine degli anni Settanta, ha postulato un pensiero debole in antitesi a quello forte e onnicomprensivo delle grandi ideologie; sarà forse che il post-moderno rende tutto incerto e liquido; sarà forse che l’individuo – e non più la “classe”, la “società”, i “partiti” – è entrato nella scena pubblica come unico elemento ordinatore dell’esistente: sarà tutto questo che determina quella propensione a definire tutti i nuovi prodotti dell’umanità post-qualcosa? Come spiegare il fatto che gli intellettuali, dagli inizi degli anni ’80, si trovano impotenti a definire l’oggetto nuovo? A capirne i processi di costruzione e definizione? Che si trovino dinanzi all’unica possibilità di prendere atto di vivere in una perenne fase di transizione? Viviamo in una post-società, in una post-democrazia, in un’era di post-politica, post-moderna e post-capitalistica, il cui maggiore prodotto è la post-verità. E naturalmente tutto il complesso magma della riformulazione e del successo della destra è post-fascismo mentre le debolezze e le problematiche della sinistra sono cristallizzate nella rassicurante definizione della post-sinistra, nata dal disfacimento del comunismo (e non manca chi sostiene che viviamo nell’era del post-comunismo). Tutte queste definizioni sembrano in realtà dire una sola cosa: viviamo in un’era di incertezza, in cui stanno avvenendo processi opachi e dobbiamo aspettare che si manifestino in tutta la loro chiarezza prima di poterli capirli per definirne gli oggetti. Insomma, non siamo in grado di creare concetti nuovi che spieghino la realtà. Allo stato attuale siamo impotenti: viviamo in una sorta di inquietudine – sentimento tipico delle transizioni, delle incertezze e dei troni vuoti – che ci spinge (forse) a non cogliere una trasformazione epocale o (forse) a coglierla ma di esserne terribilmente impauriti da rimanerne paralizzati. Allora si prendono i concetti del passato (e lo si fa in virtù del fatto che sia passato) e gli si premette un post. Si capisce che un esercizio del genere è, a conti fatti, fin troppo facile. Significa evadere un nodo – quello della concettualizzazione del reale – che mi pare fondamentale per uscire dall’impasse in cui versiamo.

La storia non si ripete
La breve e sommaria riflessione di cui sopra mi è nata dalla lettura dell’ultimo testo di Alberto De Bernardi, Fascismo e antifascismo. Storia, memorie e culture politiche (Donzelli, 2018). Lo storico bolognese pone in essere un’articolata critica alle tendenze onnicomprensive di lettura dell’attualità politica sotto il paradigma della contrapposizione fascismo\antifascismo, che si traduce in “una sovraesposizione dell’uso pubblico della storia”: fine ultimo del suo lavoro è, infatti, quello di creare un “percorso” al termine del quale il lettore “avrà acquisito una preziosa cassetta degli attrezzi, utilissima per leggere il presente fuori dagli stereotipi, dai riflessi condizionati, dalle retoriche”. Ricordando il concetto quasi ovvio (evidentemente non per tutti, soprattutto tra gli intellettuali) dell’irriproducibilità della storia e indossando gli abiti di Marc Bloch, ovvero dello storico che ha come compito “quello di ricordare all’opinione pubblica di non confondere possibili somiglianze tra eventi attuali e altri del passato”, De Bernardi si scaglia contro le tendenze ad individuare un “fascismo eterno” – Ur-fascismo secondo la celebre definizione di Umberto Eco – che “rimane un concetto dai contorni sbiaditi” perché “costruito intorno ad un’interpretazione del fascismo dai fondamenti storiografici molto labili e discutibili” e contro la sua più diretta conseguenza – l’Ur-antifascismo – che si “dibatte in contraddizioni maggiori” poiché “il tentativo di definire una sorta di antifascismo originario risulta ben più difficile”. In realtà nel mirino dello storico più che Eco si trovano quelle tendenze, ora semplicistiche ora ammuffite, pronte ad individuare – un po’ come avviene con la mafia – un carattere antropologico insito nel nostro carattere nazionale e a concepire il fascismo come un’entità polimorfa, quasi che fosse non un prodotto storico ma metafisico, una categoria dello spirito più che un’esperienza storica, un germe che si può sedimentare ovunque. Insomma, la “sintesi del male” di cui si parlava prima.

Alberto de Bernardi
Pensare il mondo oltre il Novecento
Si capisce bene che queste concezioni non fanno che affermare – come scrive De Bernardi – “un uso semplificato e banalizzato, ma fortemente evocativo, della storia” perché “in quella coppia di opposti – fascismo\antifascismo – si riassume tutta la lotta politica dell’Italia novecentesca”. E se proprio si deve cercare una “lezione” della storia, la si dovrebbe trovare nel fatto “che le crisi sistemiche cambiano la forma delle nazioni […] quanto è più dura e radicale la crisi, […] tanto più gli agenti di trasformazione scavano in profondità toccando inevitabilmente lo spazio politico”. Questa “consapevolezza” (che ricorda il migliore storicismo di Droysen e Buckhardt) dovrebbe spingere a cercare le differenze e le disomogeneità per evitare le “piste false”, le quali, però, se analizzate con l’outillage storiografico, possono racchiudere per lo storico notevole interesse, chiamando in causa “l’idea del fascismo (ma anche dell’antifascismo ndr) che transita nel discorso pubblico e si sedimenta nell’immaginario collettivo”. Così De Bernardi risale, ripercorrendo il difficile cammino dell’antifascismo, ad una serie di “occasioni mancate”, all’interno delle quali l’analisi distorta e paradossale del ventennio fascista e della Resistenza hanno prodotto altrettante distorsioni dell’antifascismo, non solo nel discorso pubblico ma anche in quello storiografico. Lo storico, infine, accogliendo il suggerimento di Norberto Bobbio, conclude: “smettiamo di utilizzare questa parola”, smettiamo di ragionare nella dialettica oppositiva schmittiana nemico\amico che si traduce nella contrapposizione fascismo\antifascismo, ma facciamo “una diuturna operazione culturale che partendo dalla ricerca alimenti una storia pubblica nuova, estranea alle vecchie guerre di memoria, capace di coinvolgere le nuove generazioni […] senza occultare il passato fascista della nazione, senza nascondere le pagine oscure della resistenza, senza esaltare il difficile itinerario dell’antifascismo, senza demonizzare la storia della Repubblica”. Al di là di un discorso molto più complesso – e non è di certo questa la sede per farlo – che andrebbe fatto sulla “tribunalizzazione della storia” (che riguarda la dialettica tra “vincitori” e “vinti”; tra “colpevoli” e “innocenti”; tra la domande che si fanno e si sono fatte alla storia e alla storiografia e all’invasività dei tribunali nel corso del ‘900), mi pare che il discorso di De Bernardi si inserisca, anche se involontariamente, perfettamente nelle domande che mi ponevo ad inizio di questo articolo. Perché riguarda quella difficoltà, quell’impotenza a concettualizzare, a depurarsi criticamente dai nodi concettuali di un passè qui ne passe pas per comprendere i processi in atto. Eppure, nemmeno De Bernardi si spinge oltre la fase correttiva del discorso. Negli intenti rimane un utile e lodevole vademecum per iniziare ad interpretare la realtà su basi storicamente corrette. Per dire, quindi, cosa non è questa nuova fase politica. Il nodo, invece, (si veda la nostra recensione a Christian Raimo) rimane: cosa è questa nuova fase politica? Dove ci porterà? Dare il nome alle cose potrebbe aiutarci a superare la paralisi e a pensare, quindi, un mondo oltre il Novecento senza dimenticarsene.
Alberto De Bernardi
Fascismo e antifascismo. Storia, memorie e culture politiche
Roma, Donzelli, 2018
pp. 170