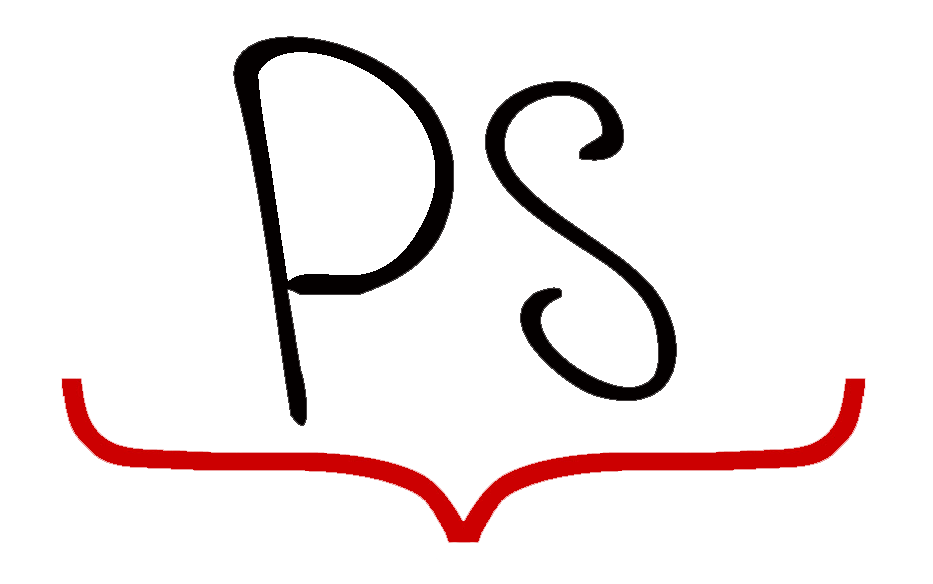Enrico Ruffino – Venezia
Banale dirlo, ma la pandemia è una crisi che va oltre l’ambito sanitario. Io credo che essa sia una crisi «totale» in virtù della sua essenza biologica e antropologica: una manifestazione repentina virulenta e di «massa» della labilità dell’esistenza acuita dalla privazione di alcune certezze radicate nella nostra società, quali – ad esempio – la consapevolezza di vivere in un mondo «libero», mobile e interconnesso a cui giustamente fatichiamo a rinunciare, soprattutto per la sua floridezza.
È però uno shock occidentale (e non solo da upper class) che spiega forse perché misure drastiche di lockdown siano state accettate e interiorizzate in Asia piuttosto che in Europa, dove questo tipo di disciplinamento sociopolitico non esiste e dove – appunto – si continua a faticare ad accettare questo tipo di privazione.
Questa constatazione serve a riflettere su una questione di grande importanza: per definizione la pandemia è un fenomeno globale ma ciò non significa che tutti gli uomini, le società e i sistemi reagiscano allo shock allo stesso modo. «Tutto il mondo è paese – ha scritto Carlo Ginzburg – non vuol dire che tutto è uguale: vuol dire che tutti siamo spaesati rispetto a qualcosa e qualcuno», vale a dire che lo spaesamento derivante da un patogeno che mina l’esistenza è comune all’umanità ma che la reazione e i mutamenti che ciò comportino si differenzino da società a società, da sistema a sistema, da uomo inserito in un ambiente a uomo inserito in un altro. In altre parole, «globale» non significa «tutto uguale».
Ciò detto, si capirà quanto certi proclami universalistici – «sarà un mondo migliore», «sarà un mondo peggiore» – siano in realtà fumo negli occhi che riflettono più le speranze, le debolezze e le angosce del momento che una reale analisi dei mutamenti in atto. Sono una spia, certo. Ma non di quello che verrà ma di quello che è in atto.
Se politica e scienza hanno iniziato a convivere forzatamente per uno stato di necessità, alla cultura – che come sempre è tagliata fuori da queste imprese – non è toccato che assolvere al suo ruolo di scrivano. Spaesata e confusa, essa si è trovata malgré soi a dover assolvere un compito che non le compete e in un certo senso la sminuisce: quello di rincuorare, di dare speranze o al contrario di prospettare scenari stigmatizzanti. Sono fioccati proclami in cui la letteratura più che una severa indagatrice della realtà è diventata la spalla su cui piangere.
La lettura è diventata il metodo per allievare le sofferenze da quarantena, per placare l’ansia, magari trovando un sorriso, evadendo un po’ dalla nuda e cruda realtà dei dati e delle statistiche. Sono comparsi articoli in cui s’invitava a leggere Boccaccio, Camus e Manzoni perché capaci di dirci «parole quanto mai attuali», per dirci come sconfiggere il «male». La lettura come «nutrimento dell’anima», uno Xanax di carta? Io dico chiaramente che l’idea di una cultura con poteri taumaturgici non mi convince affatto e anzi la ritengo dannosa. Come tutti gli ansiolitici, sedano i problemi ma non li risolvono: perché l’unica soluzione per risolvere un problema è affrontarlo.

Vengo qui alla disciplina che mi riguarda più da vicino: la storia. I parallelismi tra l’attuale pandemia e la «spagnola» del 1918 sono naturali, trattandosi di virus del tipo influenzale (a differenza dell’HIV) che hanno caratterizzato due diversi secoli. Le domande al passato si pongono nel presente e sono motivate dai i problemi che esso ci pone, dalle soggettività (di gruppo o individuali) degli storici e – oggi più di ieri – dalle domande di un «pubblico» sempre più desideroso di storia ma senza gli strumenti per poter soddisfare il proprio fabbisogno identitario.
Proprio la mancanza di questo outillage finisce per diventare anche in questo caso momento terapeutico, assurgendo la pandemia spagnola a prototipo della attuale crisi sanitaria. Le star della scienza – virologi, immunologi, epidemiologi – hanno in particolar modo iniziato ad utilizzare la «spagnola» come momento topico di una narrazione volta al contenimento dell’attuale virus. Ciò significa che il virus del 1918 non è preso nel suo contesto, messo in relazione con gli strumenti e la società dell’epoca, ma utilizzato come mero esercizio medico: dire che la «spagnola» ebbe tre cicli epidemici, che essa «ci insegna» qualcosa e che bisogna «farne tesoro», significa avvertire l’attuale popolazione che potrebbe finire come nel 1918 se non si rispettano determinate prescrizioni. Significa prendere quel virus e trattarlo a sé: non un virus che agisce in uomini immersi in un contesto, ma un virus e basta.
Volendo essere un po’ malevoli potremmo dare ragione a Foucault? Può darsi, sta di fatto che gli scienziati fanno gli scienziati con i loro dati «esatti» mentre gli storici con tutte le loro inesattezze derivanti dall’umano tocca dire la verità al potere, per citare Edward Said: ovvero che nel 1918 si usciva appena da un devastante conflitto mondiale, che il ciclo epidemico era determinato da condizioni igienico-sanitarie di guerra e che essa non permise – ma non lo avrebbero permesso gli strumenti dell’epoca – una sorveglianza attiva e un servizio di prevenzione tale da poter contenere l’epidemia in un lasso di tempo discreto.
Ciò non significa che ciò non possa verificarsi con il Sars-Cov19 – dato che il problema odierno è la fluidità della società piuttosto che le condizioni di una guerra di proporzioni mondiali – ma che una «cultura attiva» aiuta tanto la scienza quanto la popolazione a lavorare sul presente per programmare il futuro.
Non una una psico-cultura dagli esiti disastrosi, che seda e illude il lettore, ma una cultura che propone strumenti di lettura per affrontare le ansie e i problemi della pandemia senza indugiare in facili sentimentalismi e prosopope universalistiche, ma con le armi e le bellezze della complessità.