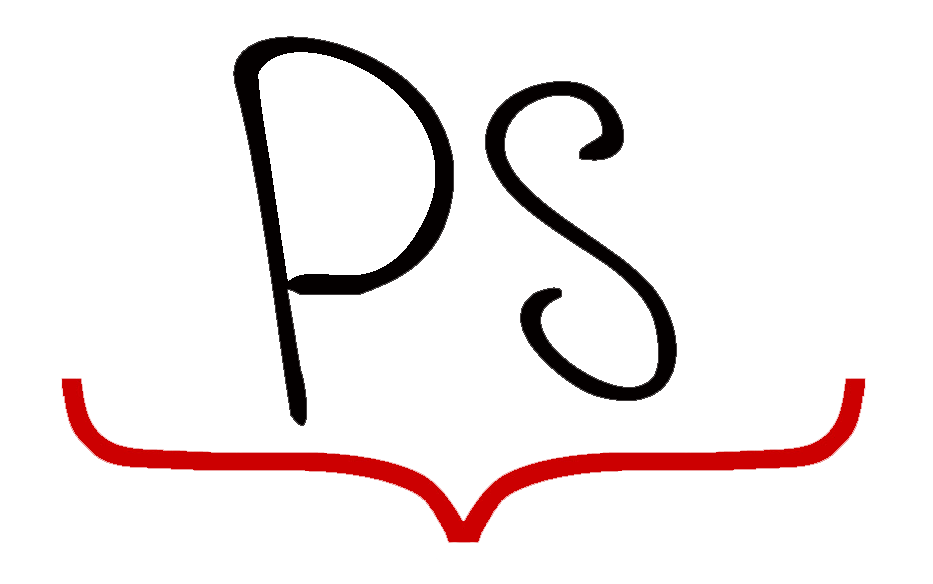Michele Santoro – Bologna
L’Italia nei secoli è diventata nota come il paese del buon cibo. Talvolta però le origini di molte pietanze, divenute ormai patrimonio dell’enogastronomia italiana, si perdono tra le pagine della storia. Sembrerà forse assurdo, ma nel nostro paese non sono pochi i casi in cui anche in momenti critici si riuscì a trovare il modo di conciliare le necessità al gusto e al piacere, uno di questi è la Castradina.
Gli eventi che oggi l’Italia si trova ad affrontare testimoniano ancora una volta la macabra ironia della sorte. Questa storia comincia, infatti, negli anni Venti ma di quattro secoli fa e precisamente in Veneto nel 1624, quando giunsero le prime notizie riguardo la diffusione della peste in Francia, Svizzera e Lombardia.
Pochi anni dopo, il morbo raggiunse il mantovano e in breve tempo tutto il nord-Italia si ritrovò in piena emergenza sanitaria. In quel periodo la carne rappresentava ancora l’alimento principale della dieta di tutte le classi sociali e la sua mancanza era quindi indice di carestia.
Quando la peste giunse a Venezia – che era impegnata nel conflitto per la successione di Mantova e del Monferrato – in poco tempo la città divenne quasi deserta. Chi se lo poteva permettere era scappato il più lontano possibile per tornare solo quando fosse passato il pericolo. Nei campi e nelle calli il silenzio, gravido di angoscia, era rotto da singhiozzi, gemiti e sospiri.
Quasi tutte le porte delle case erano sbarrate da due grandi assi incrociate che impedivano ai loro abitanti di uscire perché infetti. Dalle loro finestre pendevano dei cesti e dall’interno voci disperate chiedevano cibo, acqua e aiuto. Il contagio, oltre che il crollo demografico, comportò l’isolamento commerciale da tutte le altre nazioni e una serie di conseguenze difficili da controllare: fuga, panico collettivo, sospensione di molte attività produttive, speculazione e sciacallaggio delle abitazioni e delle botteghe abbandonate.
Sul versante orientale dell’Adriatico veneziano, ossia in Dalmazia, Montenegro e Albania, la peste non era invece riuscita a serpeggiare tra le irte montagne caratteristiche del paesaggio che sormonta tuttora le città costiere. Tra quelle terre le comunità di pastori avevano imparato da secoli a resistere ai frequenti periodi di carestia e di isolamento. Lì le carni venivano essiccate al sole durante l’estate e affumicate secondo specifiche tecniche tramandate di generazione in generazione. Una volta completato il processo venivano stagionate nei fondachi e nelle cantine per poi essere consumate durante l’anno come zuppe o vendute ai porti sui litorali.
A Venezia, nel frattempo, l’acquisto di alimenti da altri comuni italiani non era ormai più una scelta prudente e le riserve della città cominciarono a scarseggiare seriamente e con tragiche prospettive che si sarebbero senz’altro avverate se non fosse stato per merito di quei cibi poveri dei pastori slavi. Dai lidi adriatici, infatti, cominciarono ad approdare in laguna imbarcazioni schiavone, che insieme al grano e al sale portarono approvvigionamenti alimentari costituiti in larga misura da quei montoni affumicati sulle montagne balcaniche: si trattava dell’unico alimento capace di resistere a giorni di traversata senza il pericolo di deperire.

Possiamo solo immaginare come si presentasse la famosa Riva degli Schiavoni a quel tempo, brulicante di gente proveniente da tutto l’Adriatico e intenta a scaricare merci dai propri navigli. Favoriti dalle esenzioni daziali stabilite dalla Repubblica, dai Balcani i mercanti trasportavano derrate alimentari in gran quantità, ma soprattutto modalità di preparazione di questi cibi che provocarono un lento ma inesorabile cambiamento del gusto veneziano.
Ancora oggi in molte osterie lagunari si respira il profumo dei cibi balcanici, dai risi in cavroman al castrà in umido con patate, passando per l’agnello all’orientale, arrostito dopo esser stato ben unto con latte e burro. Ma tra tutti gli alimenti che potremmo elencare ne rimane uno che ancora attualmente acchiude in sé la storia della vicenda che abbiamo narrato: la castradina s’ciavona, che tradizionalmente viene consumata il 21 novembre di ogni anno, da quando Venezia istituì la festa della Madonna della Salute (1631), dedicando ad essa la celebre basilica sul Canal grande che sarà completata l’anno successivo.
Frutto di secoli di gastronomia slava, questa čorba (zuppa) dei pastori balcanici giunse in città in questo periodo di emergenza per nutrire una popolazione affamata e per risollevare lo spirito della Repubblica con i suoi sapori decisi. La carne di montone castrato veniva essiccata secondo l’antico trattamento di conservazione con sale, ginepro e rosmarino, che gli permetteva di superare indenne il periodo di quarantena. Veniva poi preparata in forma di zuppa con verze, cipolle e vino costituendo un piatto de obligo su le tole, sia dei povaréti che dei siori, nobili o mercanti. ( M. Salvatori de Zuliani 1974)

Già verso la fine del 1631 la peste era ormai passata e la capitale marciana cominciava a ripopolarsi, a riprendere i suoi traffici e i suoi affari. Le scene raccapriccianti di strade desolate e di gemiti nelle case erano ormai un lontano ricordo, ma alcuni odori nei pressi delle osterie ricordavano ancora ai cittadini il recente pericolo scampato. La castradina conquistò in breve tempo le tavole veneziane anca durante l’ano, parché la gera bona e, sora de tuto… bassa de contante!
Le importazioni di carne di castrato dalla Dalmazia crebbero notevolmente insieme ad una nuova fioritura dell’economia adriatica che comprendeva adesso pure quei pastori balcanici le cui tradizioni mitteleuropee anche culinarie erano rimaste a lungo nel silenzio. La pietanza ancora adesso, durante la festa del 21 novembre, assume il significato apotropaico della cacciata del “male” in favore della “salute”.
A pranzo con la storia:
La vicenda che abbiamo raccontato ci ha portato in viaggio dalle tavole dei pastori slavi sino alla laguna di Venezia. Ma se avessimo provato ad entrare in osteria a quel tempo, molto probabilmente avremmo potuto assaggiare una di queste due ricette riportate dagli studi del Maffioli sulla cucina originale veneziana.
Castradina cole verze:
Lasciare a bagno la castradina, secca e affumicata, per un giorno in acqua, prima bollente e poi tiepida. Lavarla in molte acque, poi tagliarla a pezzi e porla sul fuoco come un comune bollito con gli aromi d’uso. Farla bollire per un’ora, lasciarla freddare e porla in luogo fresco. Dopo un giorno togliere il grasso che si sarà rappreso in superficie, e rimettere la pentola al fuoco con le verdure del brodo tagliate in pezzettini minuti, e delle foglie di cavolo verzotto, abbondanti, tagliate a listarelle larghe due dita. Lasciar sobbollire sino a che la carne sia tenera e le verze siano cotte. Servire carne e verze col loro brodo insieme a crostini di pane.
Stufadin de castradina:
Lavare e sobbollire la castradina come sopra, poi tagliarla a pezzi e farla insaporire in un trito di cipolla, aglio, carota, e prezzemolo con pancetta e olio. Taluno, al trito, aggiunge anche della salsa o del rosmarino, o entrambi, oppure per coprire un po’ il sapore forte di questo tipo di carne, aggiunge cannella e garofano. Rosolati che siano i pezzi di carne si irrorano d’acqua o di vino bianco o rosso, si sistemano di sale e di pepe, e si portano a cottura. Originariamente il piatto non contemplava l’aggiunta di salsa di pomodoro, che poi invece s’è aggiunta. Si serve con polenta.
Consigli di lettura:
C. Coco, Venezia in cucina, Laterza, Roma-Bari, 2007
J.L. Flandrin, M. Montanari, Storia dell’alimentazione, Laterza, Roma-Bari, 2016
G. Maffioli, La cucina veneziana, Padova, Franco Muzio, 1995. (ed. originale 1982)
M. Montanari, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, Laterza, Roma-Bari, 2006
M. Salvatori de Zuliani, A tola co i nostri veci: la cucina veneziana, Franco Angeli, Milano, 1974