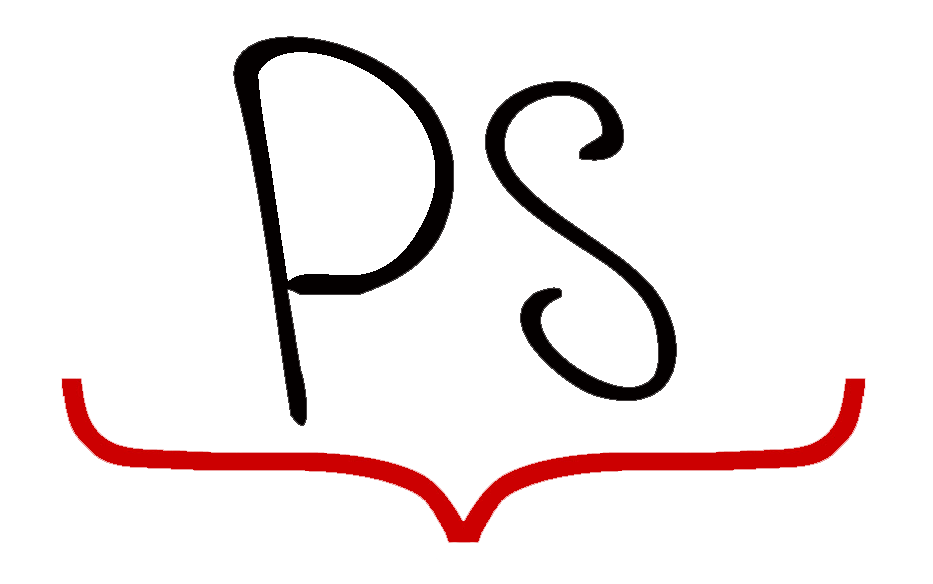Caterina Mongardini, Venezia –
Una citazione comunemente attribuita a Charles Darwin, divenuta ormai una massima proverbiale, sostiene che il lavoro nobiliti l’uomo. Negli studi di un biologo e naturalista quale Darwin fu, è possibile intuire che il concetto che si voleva mettere in evidenza era che il lavoro – in quanto attività fisica ed intellettiva, scaturita da una necessità a cui bisognava porre rimedio – avesse nel tempo stimolato le abilità dell’uomo e che questo lo abbia portato a essere capace di costruirsi, con i propri mezzi, strumenti atti ad aiutarlo nella vita. Cosicché la specie “homo” riuscì a evolversi, a nobilitarsi, a rendersi quindi superiore rispetto alle specie che, da sole, non riuscivano per natura ad essere altrettanto propositive.
Questa è, naturalmente, una semplificazione che non vuole entrare nel merito delle attuali discussioni tra specismo e anti-specismo: si limita a constatare che, di fatto, l’attività lavorativa – intesa come attività per il proprio sostentamento e quello della comunità di appartenenza – ha sempre caratterizzato l’essere umano, tanto che il lavoro è rimasto nei secoli uno dei pilastri portanti della società umana. Non fu certo casuale che uno studioso eterodosso come Darwin, nel XIX secolo abbia potuto usare proprio il verbo “nobilitare” accanto al sostantivo “lavoro”: segno di un cambio epocale, dovuto alla Rivoluzione Industriale, in cui l’etica del lavoro – adottata come religione dalle classi borghesi – poteva superare e abbattere le gerarchie di ancien régime che fino a quel momento avevano tenuto rigorosamente divise nobiltà e attività lavorative (abitudine che sarà dura a perdersi).
È una riflessione questa che mi ha accompagnato durante tutta la lettura dell’interessantissimo saggio di Giuseppe Lorentini, L’ozio coatto: storia sociale del campo di concentramento di Casoli (1940-1944), edito da Ombre Corte (2019), che ricostruisce non solo la legislazione e la produzione burocratica in materia di internamento, ma anche i contatti tra gli internati e il mondo al di fuori del Campo, restituendoci un’immagine del Campo di Casoli non così chiusa nelle sue quatto mura come si potrebbe pensare.

L’ozio coatto degli internati civili nei campi di concentramento fascisti fu inflitto come misura di accanimento su una detenzione già di per sé caratterizzata da arbitrarietà, incertezza, durezza e discriminazione. Dalle testimonianze che corredano il saggio, rinvenute grazie all’esplorazione dei documenti conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Casoli, si leva alta la supplica degli internati che chiedevano di poter lavorare secondo le loro proprie abilità: “Io sempre vissi di lavoro e non posso più sopportare l’ozio coatto dell’internamento”, scriveva al Ministero degli Interni uno di loro.
L’assenza della possibilità di svolgere un lavoro che permettesse agli internati di passare il tempo e di non perdere ciò che li “nobilitava” al di fuori del Campo di internamento è la spia macroscopica dell’intento dello Stato: disumanizzare coloro che erano stati colpiti da questo provvedimento, costringerli ad un’inattività, fisica, intellettiva e psicologica, che li conducesse all’abulia. Un provvedimento contro cui – come giustamente l’autore sottolinea e ribadisce più volte – la legge ordinaria non poteva opporsi. Infatti, la differenza tra il confino di polizia (leggi qui) e l’internamento civile (di cui il Campo di Casoli è caso studio e testimonianza), non è tanto nella crudeltà o nella durezza del provvedimento, quanto nella loro forma di fronte alla giustizia.
Mentre il confino, infatti, era stato introdotto come strumento di repressione dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (1926), l’internamento civile fu un provvedimento amministrativo, istituito nel 1940 in previsione della guerra, emanato non da un Tribunale ma dal Ministero dell’Interno contro tutti coloro che avrebbero potuto rivelarsi nemici dello Stato o contro categorie ben determinate (come gli Ebrei stranieri o i civili ex-jugoslavi). Non era dunque uno strumento giudiziario punitivo, ma uno strumento repressivo preventivo che non garantiva alcuna garanzia giudiziaria, contro il quale – di conseguenza – nessuno poteva opporsi giuridicamente. Conseguentemente, anche la quotidianità e la vita all’interno del Campo assumevano caratteri di vaghezza. Nel caso del Campo di Casoli l’autore ha messo in rilievo come il trattamento del primo gruppo che fu destinato al quel campo – gli ebrei stranieri rastrellati soprattutto a Nord che vi soggiornarono tra il luglio del 1940 e il maggio del 1942– fu diverso, più permissivo a volte e più tollerante, rispetto alle misure repressive e carcerarie imposte al secondo gruppo di internati che transitarono nel campo tra il maggio del 1942 e i primi mesi del 1944, ossia i civili rastrellati dai territori dell’ex-jugoslavia, considerati più pericolosi e classificati come “internati politici”.
Giuseppe Lorentini, facendo luce sull’internamento civile in campi di concentramento fascisti, propone nuovamente all’attenzione degli storici e degli studiosi tutti la necessità di esplorare l’universo concentrazionario istituito dalle dittature e dai totalitarismi, senza proporre paragoni arbitrari ed indebiti fra realtà nazionali differenti e senza stilare una gerarchia delle responsabilità e delle crudeltà a partire dagli scopi per i quali furono costruiti i compi di concentramento. Se, come acutamente sottolinea, la simbologia ha avuto una grande responsabilità nell’influenzare la memoria collettiva, l’assenza di filo spinato intorno agli internati civili nel periodo fascista non può esimerci dal riconoscere l’esistenza di tali luoghi detentivi, soprattutto a livello locale.

La storia del Campo di Casoli, oltre a far riemergere le tracce degli individui che vi transitarono, è importante perché messa in relazione con l’esterno del luogo di detenzione. I campi non erano isole autosufficienti, gli appalti per le mense, per il bucato delle forniture di biancheria, muovevano una microeconomia nei piccoli e lontani paesi in cui erano stati istituiti. È importante rendere noto che, in tutto il Centro Sud, furono per molto tempo attivi questi campi e che non tutti erano baracche approntate ex-novo. Quello di Casoli, ad esempio, era uno stabile del paese affittato dallo Stato i cui documenti sono stati fortunatamente conservati dall’Archivio locale. È interessantissimo capire quanto e in che misura l’esistenza di un Campo, come quello di Casoli, abbia inciso sulla comunità del luogo, quali cambiamenti apportò socialmente ed economicamente: per la storia dell’Abruzzo, Giuseppe Lorentini ha dato il via agli studi, collaborando anche alla nascita del Centro di Documentazione on-line sul Campo di Casoli, dove è possibile constatare visivamente, tramite una mappa interattiva, la quantità di campi e località di internamento libero esistiti in Abruzzo. A livello nazionale una piattaforma analoga e determinante per il censimento dei luoghi di detenzione sul territorio italiano durante il periodo fascista e il periodo bellico è “I Campi fascisti: dalle guerre in Africa alla Repubblica di Salò”. Il progetto, anch’esso corredato da mappe interattive, è attivo ed accessibile a chiunque voglia documentarsi sull’argomento grazie alla conservazione e digitalizzazione del materiale documentario – consultabile gratuitamente – concesso agli studiosi che curano sia il progetto in sé quanto i contenuti.
Giuseppe Lorentini,
L’ozio coatto: storia sociale del campo di concentramento di Casoli (1940-1944)
Verona, Ombre Corte, 2019
pp. 163