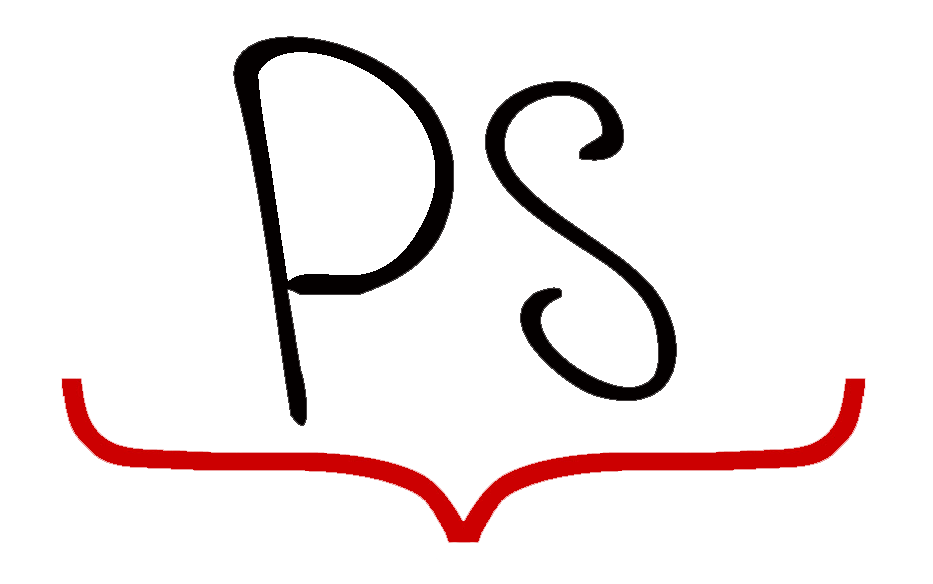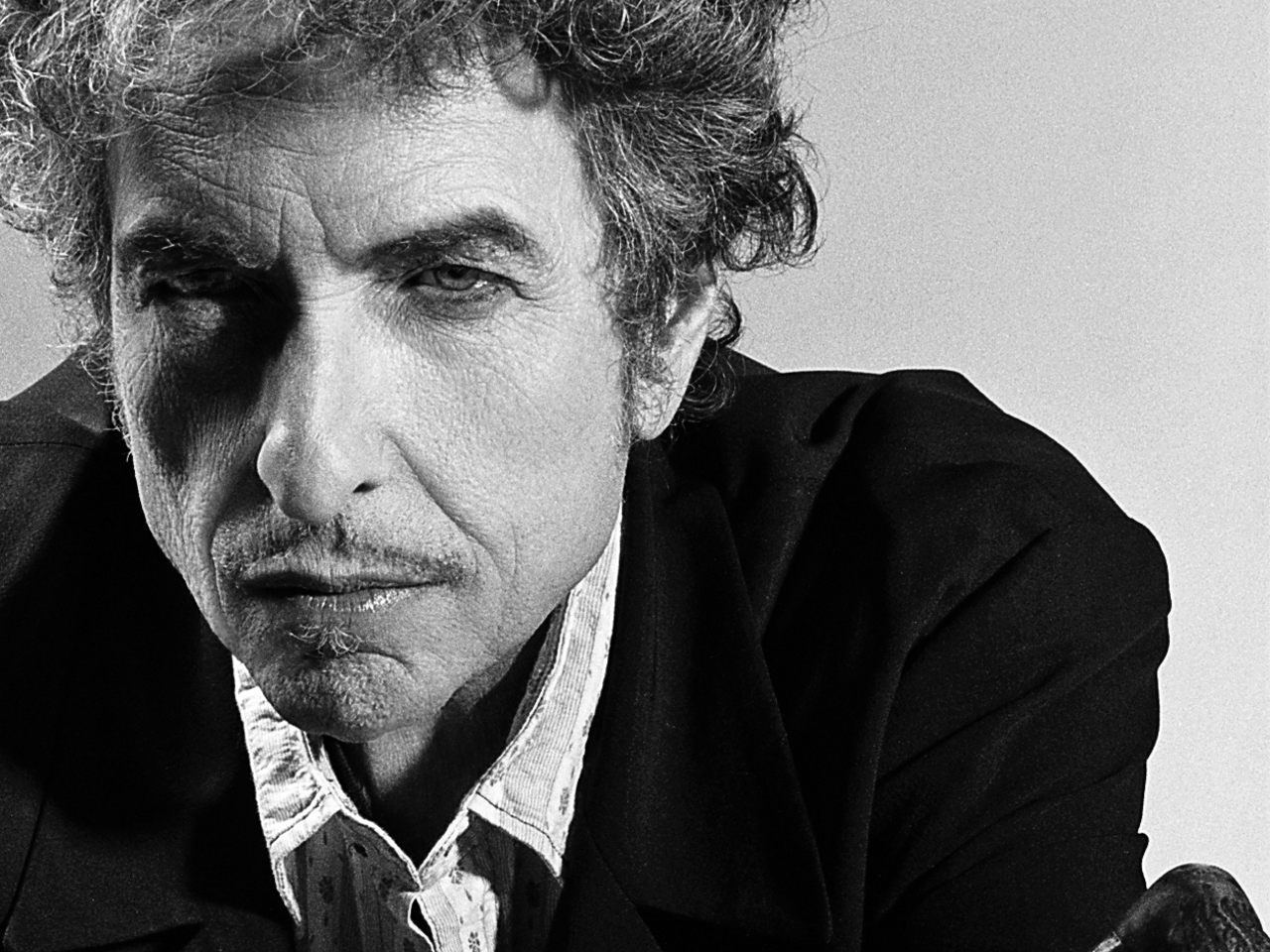
Enrico Ruffino, Venezia –
Gli autori parlano sempre dei propri libri. Ma è raro che i libri – che non siano autobiografie – parlino tanto dei propri autori. O almeno: non in maniera diretta. Di fronte alle narrazioni asettiche, prive di storia ma zeppe di analisi, possiamo leggere e rileggere il testo, apprezzarne il contenuto ma stancarci di fronte al “io” o al “noi” che mancano e agli impersonali che abbondano.
È una lezione che mi è stata data qualche mese fa, al tempo della tesi (e guarda caso da un oralista): in una narrazione storica dovremmo sempre evitare di usare l’impersonalità, che, se pur bella ed elegante, rappresenta un modo di procedere poco storico e – diciamocelo pure – poco coinvolgente.
Fare storia significa infatti confrontarsi con dei soggetti: un tempo avremmo parlato solo di oggetti di studio ma oggi, per fortuna e non senza fortissime resistenze, si può dire che non è più così.
Le vite sono entrate di diritto, a partire dalla fine degli anni ’70, nell’orbita degli interessi degli storici. Scendere di scala fino ad arrivare alle soggettività, osservare il soggetto, lavorare con le analogie e ribaltare “con una mossa di judo” (copyright dello storico Alessandro Casellato) le debolezze metodologiche in punti di forza – cioè valorizzare ciò che le fonti non dicono o dicono tra le righe – sono i mantra di due esperienze diverse ma complementari quali la microstoria e la storia orale.
Ma la storia la scrivono gli storici; e se studiano dei soggetti devono fare i conti anche con la propria soggettività: anche qui, sfatando quel mito arcaico dell’oggettività dello storico, o della sua impersonalità, lo storico parla sempre un po’ di sé. Lo fa essenzialmente perché la ricerca è sempre mossa da qualcosa di personale.
Valorizzare i soggetti, dunque. E valorizzare anche la soggettività del narratore. È forse questa una delle tante lezioni di Alessandro Portelli che da pioniere oralista non ha mai tardato a far parlare il suo io anche quando parlava delle soggettività altrui. Lo fa ancor di più in un volume appena edito da Donzelli: Bob Dylan. Pioggia e veleno (Donzelli, 2018) che non tarderei a definire un “libro-specchio”. Nelle righe seguenti vorrei esplicitare meglio questa definizione.

Pioggia e veleno inizia con un ricordo e finisce con una speranza. Inizia con un Io al passato e finisce con un Noi (o con un voi?) al futuro. L’incipit è un incontro avvenuto:
«A Hard Rain’s A-gonna Fall» è la prima canzone di Bob Dylan che sia stata trasmessa alla radio in Italia. Lo so perché a trasmetterla sono stato io, nel 1964.
Il finale è un incontro non avvenuto ma che non è detto che non avvenga. È una speranza:
Dylan: «Ma nei tempi antichi golia fu ucciso e oggi la gente non fa che dire quanto era crudele golia. Oggi ci sono golia più crudeli che fanno cose più crudeli. Ma un giorno saranno uccisi anche loro». Forse no. Ma la storia non è ancora finita.
Tra l’inizio e la fine, tra gli incontri passati e quelli futuri, c’è il racconto. E in questa narrazione continua ad esserci un Io che mai risulta invadente né stucchevole. È l’io di chi sente non tanto l’esigenza di spiegare perché un libro quanto piuttosto il come è avvenuto l’incontro con il proprio soggetto di studio.

Dico questo perché l’autore esplicita sin da subito che questo libro – scritto per “la benvenuta insistenza di Carmine Donzelli” – non è stato programmato in quanto, in un passato ormai remoto:
io ho preso una strada e lui [Bob Dylan, ndr] ne ha prese molte altre (forse si starà ancora chiedendo quante ne deve percorrere prima di decidere chi è). Le cose che cercava lui non erano quelle che ho cercato io. Qualcuno ha detto di essersi sentito tradito; io no.
Come in quegli amori che all’inizio sembrano totalizzanti e infiniti, ma alla resa dei conti finiscono con una separazione consensuale, anche gli incontri di studio o le passioni musicali possono essere soggette a questo iter biografico. Non esistono idilli infiniti. Le storie di vita sono belle perché impensabili: le strade che la vita ti pone davanti non sono mai programmate, sono sempre mutevoli e inattese. Mai ti aspetteresti di prendere strade diverse da quelle del tuo compagno di viaggio.
Eppure la vita è fatta anche di separazioni. Ma non è detto che, per eventi imponderabili e del tutto imprevedibili, tu non finisca a parlare del passato, di vecchie passioni e amori persi. Portelli, il cui evento imprevedibile che lo ha tirato “per i capelli” a parlare di Dylan è stato il Nobel conferito al cantautore statunitense, lo sa. E ce lo dice.

Insomma, non c’è un vero e proprio perché di questo saggio, si tratta di uno di quei “libri non programmati”, nati da un’insistenza esterna, e non un’esigenza interna, e da una lezione tenuta al Salone del Libro, senza alcuna pretesa di pubblicazione, una di quelle ricerche “nate per caso” che risultano fruttuose tanto più se danno la possibilità al lettore di immergersi in una storia, che non è solo quella di Hard Rain.
In questo senso il come, almeno per chi scrive, è più importante del perché: c’è una grande storia, a tratti inedita, in alcune parti narrata tra le righe, che mi suscita interesse ed entusiasmo. Una storia che inizia con una borsa di studio negli Stati Uniti a fine anni ‘50; che attraversa due paesi, due continenti, diverse culture – popolari, della protesta, operaie, Statunitensi, italiane – passa attraverso la politica, la musica e i musicisti: l’incontro di Francesco De Gregori con Dylan e l’incontro di Portelli con Bennato attraverso Dylan.
La generazione “senza padri” (e, nel caso di Portelli e molti altri storici di quella generazione, anche senza “maestri”) di cui Dylan si fece portavoce e cantore. Il testamento dell’avvelenato che diventa musica popolare tra i cantori e Lord Randal che si spinge più in là, verso lidi lontani. Dall’Italia del ‘600, al Regno Unito fino agli Usa, il tutto attraverso una tradizione orale. Gli idilli che nascono e poi finiscono. Le strade che si perdono e le etichette che vengono rifiutate.
C’è tra queste pagine un racconto prezioso sugli anni ’70 ma ancor di più sui ’60. Anni, quest’ultimi, molto spesso snobbati in favore delle “mostruosità” dei ’70 ma che in realtà racchiudono quella potenza immaginativa che andrà a distruggersi nel corso del decennio successivo: il decennio dell’immaginazione contro il decennio della distruzione. Sì, è forse possibile fotografare un ventennio così; ma in questi anni, e per questa generazione, la musica assume valori diversi.

Perché la musica è un catalizzatore sociale, che permette di stringere legami, di dar vita ad amicizie e far nascere sentimenti di fratellanza. La musica crea un immaginario. È visionaria ma anche – e non potrebbe essere altrimenti – identitaria: cos’è un inno se non uno strumento che stringe un intero popolo attorno ad una bandiera? Chi canta l’inno mette la mano al cuore perché si sente un appartenente ad una comunità nazionale, chi cantava Bandiera rossa si sentiva comunista.
Il fascismo faceva cantare Giovinezza per stringere attorno a sé la gioventù. Ma la musica in questo ventennio è anche altro. È strumento di studio per il suo valore sociale. Lo ha detto, con una sorta epigrafe autobiografica, lo stesso Portelli nell’ultimo numero de la rivista Il de Martino (dedicato ad un’antologia di saggi musicali dello storico) intervistato da Antonio Fanelli (con un estratto sul Lavoro culturale):
devo dire, insomma, di musica ne deve scrivere gente che ne sa di più, perché alla fine io ho sempre ragionato più sul rapporto tra musica e contesto sociale che sulla musica in sé e come tale, e anche per questo ho finito per spostarmi sempre di più sulla storia orale, proprio perché come competenza critica capivo meglio le storie che non le musiche dei canti di cui mi occupavo.
Lasciare la musicologia ai musicologi e occuparsi delle sue valenze sociali. Niente di più chiaro, e di più umile, per una personalità intellettuale che ha rivoluzionato l’approccio alle fonti orali. E cos’è la musica se non una fonte orale?
In Pioggia e veleno l’intellettuale romano lo dice chiaramente, in una nota, quando parla, mostrandoci l’importanza e la funzione dell’oralità nella storia, della trasmissione del “testamento dell’avvelenato” che “è attestata per iscritto già a Verona nel 1629 e a Edimburgo nel 1710. Ma non è così che l’hanno imparata Carmela Luci, Jeannie Robertson e generazioni di loro simili; e sarebbe morta lì se loro non l’avessero cantata e trasmessa oralmente.” Ma ce lo dimostra ancora di più quando si spinge in un’incredibile esegesi filologica del testo di Dylan tanto da far dire ad Andrea Colombo di aver dimostrato “una mostruosa erudizione”.
Qui arrivo al punto cruciale e mi avvio alla fine: anche attraverso la “mostruosa erudizione” Portelli involontariamente sta parlando di sé. Stiamo parlando della parte analitica del testo, quella in cui il come è già stato raccontato e ci si avvia nell’analisi dura e pura (blue eyes; my young one).

Alessandro Portelli
Eppure, anche lì, Portelli spiega il suo percorso. Questa volta senza spiegarlo. Perché quella “mostruosa erudizione” è sì frutto di un intelletto eccelso ma è anche una metodologia precisa – all’italiana – che l’intellettuale ha strutturato e affinato nel corso degli anni con ricerche empiriche, sul campo, attraverso la pratica dell’intervista (Giovanni Levi, uno dei padri della microstoria, ha voluto precisare che la microstoria fa storia nel villaggio e non del villaggio. Lo stesso fa la storia orale).
Ed è anche frutto di una stagione, quella che va da metà anni ’70 ad inizio anni ’80, in cui l’esigenza di scendere di scala, di approcciarsi con un atteggiamento microanalitico ai fattori testuali, narrativi, mentali, soggettivi – dalle rielaborazioni culturali di Menocchio impresse da Ginzburg nel ‘76 alle storie di vita e alle memorie di Terni (guarda caso pubblicate all’interno della collana Microstorie Einaudi) di Portelli – diventava imperante. Filologia contro generalizzazione. Micro contro macro. Tutto quello che oggi appare sormontato dalla global history (ma c’è chi – come Francesca Trivellato e Giovanni Levi – ha proposto con grande intelligenza una “microstoria globale”. Ci chiediamo se possa esistere una storia orale globale.) non sembra passato per esponenti storici di quell’esperienza come Alessandro Portelli.
Pioggia e veleno è un testo di microstoria che parla, in ogni sua argomentazione, volontariamente e involontariamente del suo autore. È un libro specchio in cui l’autore si guarda in continuazione, anche senza volerlo. Anche quando dice:
Il punto, infatti, non è che per riconoscere figure come Dylan dovremmo aggiungere nuove categorie, ma piuttosto che dobbiamo ripensarne la definizione, la delimitazione dei confini, e in ultima analisi l’utilità stessa di suddividere per categorie i saperi e le arti. Le categorie separano le arti e i saperi in sfere incomunicanti; artisti come Dylan le mescolano, le scavalcano, le confondono, ci fanno dubitare e cercare ancora – che poi è la funzione delle arti e della letteratura medesima. Dylan non appartiene alla letteratura perché non ce lo possiamo chiudere dentro.
Eppure, a leggere questa frase, potremmo dire lo stesso di Alessandro Portelli.